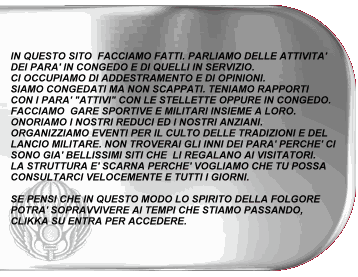Pubblicato il 09/08/2014
AL MEETING DI RIMINI PARLA IL GIORNALISTA DI GERRA GIAN MICALESSIN

RIMINI – al Meeting ospite Micalessin:
«Vi racconto la mia vita da reporter che ho sognato fin da bambino»di Rodolfo Casadei
«Il mio incubo era l’Armata Rossa. Fin da piccolo leggevo reportage su Vietnam e Afghanistan. Oggi faccio l’inviato di guerra». A tu per tu con Gian Micalessin
Una bella fortuna per il Meeting di Rimini poter contare da anni sul contributo di Gian Micalessin, uno dei migliori inviati speciali e corrispondenti di guerra del panorama giornalistico italiano. I suoi reportage sono apparsi su Channel 4, TF1, France 2, Tsi, RaiNews24, Rai 1, Rai 2, Canale 5, La 7. I lettori di Tempi lo conoscono bene per i suoi servizi dalle aree calde del mondo.
Da un decennio insieme a Roberto Fontolan (Avvenire, Il Sabato, Il Sole24Ore, Rai) dà vita alla serie “Storie del mondo – Rassegna di reportage internazionali”. E dopo dieci anni ha voglia di fare un abbozzo di bilancio di quanto fin qui fatto.
«La prima considerazione da fare è che per 10 anni abbiamo riempito le sale del Meeting, contraddicendo l’opinione dominante che questo genere non “tira”.
In Italia si continua a dire che i documentari e le storie del mondo interessano poco e fanno poca audience, ma al Meeting per una serie di ragioni siamo in controtendenza. L’anno scorso per quattro sere abbiamo riempito una sala da 1.200 posti. Un pubblico selezionato e sensibile a certi temi come quello del Meeting è interessato.
Questo implica che anche la televisione italiana, soprattutto quella pubblica, dovrebbe puntare a un’informazione che guarda a questo tipo di prodotti, per un pubblico più attento e più selezionato».
“Storie del mondo” ha un suo Dna, una cifra intellettuale e stilistica ben riconoscibile. «Insieme a Roberto Fontolan, il vero ispiratore dell’iniziativa, puntiamo sempre a raccontare storie che mettono in evidenza l’umano nelle persone e nei popoli. Cerchiamo storie che abbiano un alto grado di umanità e di conflittualità umana al proprio interno. Perché questo è ciò che genera più attenzione e più capacità da parte del pubblico di riconoscersi nelle storie che raccontiamo, nei particolari sentimenti dei protagonisti. La rassegna è il tentativo di spiegare quello che succede nel mondo attraverso storie di esseri umani».
Sono passati più di trent’anni da quando Gian Micalessin ha cominciato il lavoro di inviato e corrispondente di guerra. Molte cose sono cambiate, molte sono rimaste uguali. «Il compito dell’inviato continua a essere lo stesso: aprire un canale di comunicazione fra chi sta lontano e chi sta al centro di un dato avvenimento. Molto spesso il canale è rappresentato da una storia di esseri umani. Solamente aprendo questo canale su cui scorrono sentimenti comuni ed emozioni tu riesci a far partecipare chi sta lontano a quello che succede, al dramma di chi vive quell’esperienza. Questo internet per un verso e le agenzie di stampa per l’altro non riescono a farlo. Lo può fare solo l’inviato, e le cose continuano a stare così. Quello che è cambiato, è anzitutto la velocità dell’informazione. Quando ho cominciato a fare questo lavoro nel 1983 con Almerigo Grilz e con Fausto Biloslavo, stavo via mesi. Per un reportage in Afghanistan stemmo via due mesi e mezzo. Tornammo e vendemmo quel reportage girato fra le montagne dell’Afghanistan alla Cbs, che ne mise in onda 20 minuti. Era un reportage vecchio di due mesi e mezzo: oggi sarebbe impensabile riuscire a vendere materiale di questo tipo, perché l’informazione è diventata frenetica. Oggi un reportage non può essere più vecchio di una settimana. I tempi dell’informazione si sono accorciati, sono diventati frenetici. L’informazione ha acquistato in freschezza, ma ha perso in spessore, e raramente coglie la complessità».
Vocazione ai fronti caldi
Per Micalessin il giornalismo, e in particolare quello di guerra, è una vera e propria vocazione, “sentita” sin da bambino. «Da piccolo, anche quando eravamo in vacanza, costringevo mio padre a portarmi davanti a un televisore alle 20, quando veniva trasmesso il telegiornale, per poter vedere i reportage di Marcello Alessandri sulla guerra del Vietnam. A dodici anni ho letto uno dopo l’altro i romanzi di Oriana Fallaci. A 19 già sognavo di partire per l’Afghanistan: stavo finendo il liceo e i sovietici avevano invaso quel lontano paese. Leggevo i reportage di Ettore Mo e scoprivo quella strana guerra dove le popolazioni civili si ribellavano perché i sovietici gli impedivano di studiare la religione a scuola. Poi va ricordato che per lavoro mio nonno aveva navigato per tutta la vita, e quand’ero bambino mi raccontava storie di paesi lontani. Infine, io ero nato e vivevo in una città di confine, Trieste, a 10 minuti di auto da una frontiera che allora coincideva con la Cortina di ferro. Mentre il resto d’Italia non ne aveva consapevolezza, noi vivevamo con l’incubo di essere invasi dall’Armata Rossa e di restare dietro le linee italiane in un ipotetico conflitto. Per questo in noi c’era una naturale attenzione a quello che succedeva sui confini. Quando l’Armata Rossa, l’esercito che turbava i miei sogni di bambino, invase l’Afghanistan, subito pensai che quella sarebbe stata la prima guerra che avrei raccontato».
Oggi grazie alle nuove tecnologie e ai social network una quantità enorme di notizie e di filmati di provenienza internazionale si riversa sul pubblico. Sono nate figure come il citizen journalist (giornalismo partecipativo, ndr), e persino i combattenti jihadisti producono documentari. Ma la figura dell’inviato resta insostituibile.
«Quando andavamo in giro negli anni Ottanta, i committenti ci dicevano: “Portateci le sparatorie, i morti, le armi in mostra”.
Oggi questo non ha più senso come lavoro dell’inviato, perché se ne trovano a bizzeffe sul web. Il problema è che questa abbondanza si rivela anestetizzante: non dà più nessuna emozione vedere un morto online. Quello che invece deve fare l’inviato, è farti capire che cosa c’è dietro a ciò che succede. L’esempio più significativo che mi viene in mente è quello della Siria. Fino al 2012 sembrava che il regime di Bashar el Assad, da quello che ci raccontava un’informazione completamente omologata, fosse sul punto di cadere e che in quel paese fosse in corso una guerra combattuta da un gruppo di specchiati democratici amanti della libertà contro una dittatura che massacrava tutto il popolo. Bastava andare in Siria per accorgersi che non era così. Ma che ci si trovava di fronte a una spietata guerra civile dove non c’erano buoni né da una parte né dall’altra, e dove il 50 per cento della popolazione stava ancora con il dittatore perché lo considerava il male minore rispetto a bande di tagliagole, assassini e massacratori. Tutto questo non traspariva dalle notizie e dai filmati sul web, anzi si capiva esattamente il contrario. Cioè l’immagine di un regime che non avrebbe resistito alla rivolta popolare e sarebbe caduto. maloula-cristiani-hA tre anni di distanza vediamo che quel regime è ancora in piedi e che la maggioranza della popolazione lo sostiene ancora. E vediamo pure che quelli dell’altra parte non erano dei democratici, ma in gran parte dei fanatici musulmani. Senza gli inviati non saremmo arrivati a questa comprensione».
Curiosità e coraggio
Resta un’ultima domanda da rivolgere a Micalessin, quella che gli fanno i colleghi più giovani: di che cosa ha bisogno un inviato dentro di sé, e di che cosa ha bisogno fuori di sé, nel senso della strumentazione necessaria. «Dentro di sé deve avere tanta curiosità e la capacità di godere del proprio lavoro. Deve chiedersi sempre perché qualcosa succede, chi c’è dietro a quello che succede. Le cinque domande principali restano valide: chi, cosa, come, quando e perché. Per quanto riguarda la strumentazione, non ci vogliono grandi cose. Un taccuino e una penna sono ancora oggi quello che basta, perché è ciò che serve quando sei sul terreno, per appuntarti quello che succede attorno, per segnarti i nomi, per non dimenticare nulla. Gli strumenti per trasmettere il tutto vengono dopo. Quel che serve veramente è la curiosità e la voglia di capire». Chi parteciperà all’edizione di quest’anno di “Storie del mondo” non resterà deluso. Ci sono alcuni documentari da non perdere. Uno del giornalista spagnolo Fernando De Haro sulla difficile situazione dei copti in Egitto; uno sulle volontarie che soccorrono i migranti lungo la frontiera fra Stati Uniti e Messico; uno sulla visita di papa Francesco in Terra Santa e uno dello stesso Micalessin su Maloula, l’antica cittadina cristiana in Siria contesa fra jihadisti e governativi.