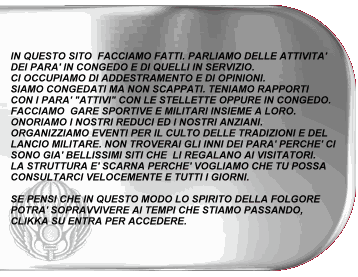Pubblicato il 14/09/2018
“….PER IL BENE INDISSOLUBILE DEL RE E DELLA PATRIA. VIVA LA REPUBBLICA, VIVA L’ESERCITO!” di Marco Bertolini

Pubblichiamo un articolo del gen Marco Bertolini, che apparirà sul numero dela Rivista Folgore in stampa questo mese
“….PER IL BENE INDISSOLUBILE DEL RE E DELLA PATRIA. VIVA LA REPUBBLICA, VIVA L’ESERCITO!”
Prima della deriva degli ultimi decenni, scanditi annualmente dalla saga dei film stupidi e volgari delle “Vacanze di Natale a ….”, la cosiddetta cinematografia leggera italiana sapeva produrre opere di grande livello. Sarà stato l’influsso del Verismo dei grandi registi italiani del passato o l’esistenza di autori e attori che sapevano cogliere aspetti della nostra “italianitudine” poi passati di moda, ma è certo che si sapeva incidere sulla storia di quella nuova Musa in maniera indiscutibile e memorabile, con scene e capolavori di recitazione indimenticabili. E’ il caso della serie di Peppone e Don Camillo, partoriti dalla penna agrodolce di quel genio che era Giovannino Guareschi, insuperabile nel descrivere gli aspetti più spassosi e umani della società contadina uscita dall’ultimo dopoguerra. I più anziani ricorderanno bene, ad esempio, la scena di Peppone impegnato in un comizio contro la “reazione clericale, atlantica, guerrafondaia …. che tutti ben conosciamo!” nella Piazza di Brescello, sabotato da quell’impenitente di Don Camillo che lancia a tutto volume le note della Canzone del Piave dagli altoparlanti del campanile. In quell’ingenua e certo eccessivamente generosa ricostruzione del clima di quei tempi, alle prime note dell’inno Peppone cambia registro, producendosi in un infoiato discorso patriottico di tenore opposto a quello voluto e concludendolo con la sincretica affermazione riportata nel titolo di queste riflessioni.
Non c’è dubbio che la finzione cinematografica non teneva conto che in misura limitata della realtà, ancora segnata dalle distruzioni e dai lutti causati dall’ancora recente guerra civile, ma certamente coglieva l’essenza di valori condivisi che non erano ancora stati erosi completamente e che consentivano a bianchi, rossi e neri di riconoscersi in alcuni simboli aggreganti e di lavorare assieme per ricostruire un paese distrutto moralmente e materialmente.
In fin dei conti, credo sia soprattutto questa la differenza tra la società italiana di allora e l’attuale: la sostanziale scomparsa di valori di fondo condivisi che consentano di operare assieme per superare una congiuntura morale, prima che economica ed internazionale, spaventosa. Insomma, non è più un’Italia che si divide di volta in volta sui programmi, sulle alleanze, sulle ideologie di destra o di sinistra, sull’economia per puntare allo stesso fine, il bene comune; si tratta invece di due Italie diverse, per le quali l’indipendenza nazionale non è più quello spazio “al di fuori delle contese” dal quale partire per trovare una sintesi. Due Italie che avrebbero bisogno di due diversi governi per potersi sviluppare in pace, senza che ogni provvedimento venga impugnato dall’altra per spaccare tutto e per far schiattare i filistei con Sansone. Infatti, per la prima volta nella nostra storia unitaria è proprio l’indipendenza, oggi declinata col termine di sovranità, che viene brandita come un’ascia per colpire l’avversario, anzi, il nemico. Essere a favore o contro l’indipendenza nazionale è infatti la vera cifra dello scontro politico odierno, una linea di faglia trasversale a tutti gli schieramenti tradizionali assolutamente nuova che impedisce al nostro popolo di definire se stesso in relazione agli altri, preso com’è nell’opera di differenziarsi dal nemico interno. Per questa definizione, infatti, avrebbe la necessità di individuare congiuntamente quali dei suoi interessi non devono essere nelle disponibilità altrui, a partire da quelli più politicamente scorretti, come il diritto ad essere composto in linea di massima da gente affine, che usa sostanzialmente lo stesso linguaggio per comunicare, che è accomunata da uno sviluppo storico riconoscibile e comune nei tratti essenziali, che condivide le stesse tradizioni e un simile impianto culturale, spirituale e religioso, trafilati per secoli o millenni di evoluzione. Avrebbe bisogno di individuare quali sono le minacce alla propria natura di comunità unitaria, facendo in modo che eventuali minoranze etniche rimangano tali e non trasformino il loro diritto a un’integrazione regolamentata ed ordinata nel potere di imporsi sulla generalità della popolazione, alterandola; avrebbe bisogno di progettare un futuro possibile per le generazioni venture, coltivando il giusto desiderio che non ripudino quanto per loro è stato fatto in passato e coltivandone anzi la memoria; avrebbe bisogno, in definitiva, di essere orgogliosa di se stessa, senza rinunciare al desiderio di incidere ancora sulla storia.
Ma è proprio questo il problema. L’Italia non può essere orgogliosa di se stessa “per costruzione”. Avrebbe bisogno, a tal fine, di potersi riconoscere nella sua storia completamente, senza quelle amputazioni che, per renderla politicamente corretta, la snaturano. E’ ovvio il riferimento al “deprecato ventennio” del quale pare lecito ricordare solo gli aspetti negativi, ma più in generale è tutta la nostra storia a soffrirne, a partire da quella più nobile e antica riferita all’Impero Romano o a quella della civiltà cristiana da noi originatasi, per la quale Roma ha ancora una valenza universale. Esaltare oggi le caratteristiche di quelle fasi, che contraddicevano palesemente la nostra supposta passività ed anzi furono caratterizzate da una innegabile e per molti versi analoga vocazione espansiva, sarebbe improponibile a meno di sottoporsi costantemente al ditino alzato dei guardiani delle nostra ortodossia democratica, pacifista e rinunciataria, mai paghi nel ricordarci di quali malefatte sarebbe fatto il nostro passato. E’ chiaro che per questi non rappresentiamo, proprio a causa della nostra origine, un’entità degna di sopravvivere quale realtà autonoma, indipendente, con proprie caratteristiche distinte da quelle degli altri popoli.
Insomma, una delle due Italie non vuole più essere tale, ansiosa certamente di confluire in una Comunità internazionale che le eviti il fastidio di esercitare la responsabilità della propria indipendenza, come forse alcune giovincelle vogliono sbarazzarsi al più presto della propria noiosa virtù convinte così di approdare più facilmente all’appagamento e alla libertà. E per far questo, rifiuta la costrizione nei limiti che la natura o Dio le ha imposto e che non riguardano soltanto il territorio, ma tutto l’essere nazione. Oltre ai confini territoriali, infatti, che vorrebbe porosi e a disposizione di tutti, snobba quelli culturali non necessariamente compresi nei primi, che ci vedono da millenni caratterizzati da un sentire e da un modus vivendi peculiare e ben individuabile, origine e frutto al tempo stesso delle eccellenze artistiche e scientifiche che nello Stivale hanno visto la luce. Da qui, l’enfasi su nostre supposte ed inarrivabili criminalità congenite, per le quali dovremmo cambiare radicalmente e smettere di essere noi stessi, consegnandoci a braccia alzate a qualche rieducatore di buona volontà. Viva il “Royal baby” e il “Royal wedding” di turno, quindi, ai quali rendere omaggio nei ciclici pellegrinaggi oltremanica da parte di frotte di entusiasti sudditi e succubi delle identità e regalità altrui; ma abbasso i riti della nostra ripudiata realtà nazionale e statale. E che cada, finalmente, quella nostra oscurantista religiosità che ha fatto nascere, con il cattolicesimo di cui eravamo la patria, la nostra identità: un’identità capace di far coesistere differenze che non possono non sussistere in un paese che si estende dall’arco alpino alle coste siciliane ma che costruiva ovunque le stesse chiese nelle quali si veneravano con lo stesso “latinorum” gli stessi Santi e le stesse lacrimevoli Madonne. Anche sotto il profilo antropologico, questa Italia a-italiana vuole trasformarci in senso multirazziale (la parola razza è declinabile solo in questo termine, ovviamente) spasimando per afflussi indiscriminati di popolazioni a noi estranee non solo per il colore della pelle, quanto soprattutto per percorsi storici e culturali che ne rendono impossibile l’integrazione. Queste, non si dovranno limitare a rappresentare un’ulteriore minoranza da includere, con i suoi usi e la sua cultura come per gli Italiani nel Canton Ticino, gli albanesi in Puglia e Calabria o gli austriaci in Alto Adige, ma dovrebbero frammischiarsi caoticamente con noi, per produrre un “melting pot americano” nel quale tutte le differenze vengano mischiate, frullate, appiattite, omologate. Ma se questo era comprensibile nel Nuovo Mondo che si andava popolando di un’immigrazione indiscriminata, stracciona e randomica che aveva facilmente ragione delle poche popolazioni autoctone non ancora arrivate all’epoca del ferro, non è possibile nella nostra Europa, nella quale convivono identità solide basate su percorsi storici, culture, lingue trafilate in millenni di evoluzione.
Tra le molte vittime di questa situazione meritano una menzione particolare le Forze Armate. Per loro, infatti, quel ripudiato patrimonio di storia, tradizioni, valori culturali e spirituali, quell’orgoglio nazionale che qualcuno vorrebbe reprimere rappresentano uno strumento operativo fondamentale. E’ l’unica forza, superiore al biasimo degli altri, all’indignazione degli ipocriti, alla prudenza dei pavidi ed ai calcoli dei cinici, alla quale possono attingere per combattere, se necessario, anche battaglie perse in partenza, come accadde ai Danesi all’inizio dell’invasione tedesca di tre quarti di secolo fa. Ad esse, infatti, non è affidata semplicemente la repressione della criminalità come nel caso delle Forze di Polizia, ma proprio la difesa dei confini, a partire da quelli territoriali, nonché l’affermazione di un’identità che sappia sopravvivere anche a congiunture nazionali drammatiche e distruttive. Lo devono poter fare a ragione o a torto (si, anche a torto!), per gli interessi di quella nazione che qualcuno nel nostro caso considera sostanzialmente cattiva, da rieducare: una roba di cui vergognarsi. Per questo, nella “liturgia” militare, che solo a qualche politico sciocco o in mala fede potrebbe venire in mente di de-formalizzare (cosa già sentita), simboli come la Bandiera, il saluto, l’uniforme e addirittura le sfilate, i pennacchi dei corazzieri e gli ottoni delle fanfare sono importanti quasi come gli strumenti operativi, le armi, che devono saper utilizzare; e questo perché ricollegano i militari non solo a un compito contingente da affrontare, sia esso l’impegno operativo o la routine in guarnigione, ma perché esprimono la continuità della loro funzione principale, quella di presidio insostituibile dell’indipendenza nazionale, senza la quale sarebbero solo prezzolati mercenari al soldo dell’uomo della provvidenza del momento. Anche per questo, è ridicola ed offensiva la definizione di “dual-use” per le Forze Armate, come se un sommergibile potesse essere, a pari dignità e al tempo stesso, affondatore di navi e recuperatore di reti da pesca incagliate sul fondo. Ed è immorale il tentativo di accelerare la smilitarizzazione strisciante delle Forze Armate facendo degenerare il virus della rappresentanza militare impiantato sull’onda del ‘68 in metastasi di una sindacalizzazione vera e propria, in modo che la cultura del dovere sia definitivamente sostituita da quella dei diritti.
Faremmo bene a considerare con la dovuta attenzione questi aspetti, mentre si continua come treni a ridimensionare lo strumento militare, con particolare riferimento a quello terrestre dove in nome di quel “dual-use-ismo” di cui sopra pochi si scandalizzano se i carristi sono senza carri, i paracadutisti senza paracadute e tutti senza munizioni; tanto qualcos’altro da fargli fare per tenerli occupati lo si troverà comunque, senza fargli esibire una marzialità che insospettisca chi ne temesse l’impiego “solo” per la difesa della nostra indipendenza.
E questa riflessione è particolarmente necessaria e doverosa nel centenario della Vittoria della prima guerra mondiale – che alcuni celebreranno con un bel po’ di faccia tosta – quando fu chiesto ad altri uomini con le stesse stellette che brillano sui baveri dei soldati di oggi di combattere e di morire per la nostra dignità di padroni a casa nostra, senza troppe preoccupazioni per la “cultura della sicurezza” a sua volta brandita oggi per snervare quello che resta della virilità militare. Combatterono e morirono semplicemente per il Dovere, senza barricarsi dietro alcun diritto, in difesa di confini che non si vogliono più, forse anche da parte di molti che per giuramento analogo a quello dei soldati ne dovrebbero essere custodi gelosissimi, per investitura politica o popolare.