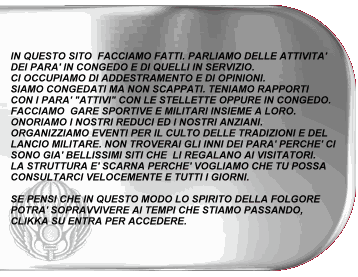Pubblicato il 17/09/2014
RASSEGNA STAMPA – L’ESPRESSO DEL 18 SETTEMBRE 2014
ESPRESSO 38
sezione: SOMMARIO data: 25/9/2014 – pag: 26
Mondo AFGHANISTAN
ritirata da Kabul
A dicembre e dopo 13 anni i soldati della Nato lasceranno il Paese. Ecco tutti i piani di un rientro difficile. Con l’incubo dei talebani. E il dubbio che sarebbe meglio restare
DI GIANLUCA DI FEO – FOTO DI LUCIA FERRARIOLa commemorazione della morte di Massud, il leggendario comandante che ha sconfitto i russi e tenuto testa ai talebani, è sempre stata uno dei rari momenti di unità nazionale in Afghanistan.
Invece la scorsa settimana la cerimonia della Loya Jirga, la grande assemblea dei capi tribali, si è trasformata in una rissa, con il presidente uscente Karzai costretto a lasciare la tribuna prima che dagli insulti si passasse alle armi. Tredici anni fa, l’uccisione di Massud da parte di un kamikaze qaedista era stato il segnale per l’attacco alle Torri Gemelle, ma anche l’inizio dell’intervento statunitense con la liberazione del Paese dal terrore fondamentalista. Adesso Kabul scivola verso il caos, con due candidati e due etnie che litigano per la presidenza mentre la paura della guerra civile si fa sempre più concreta. Un altro incubo per la Casa Bianca, che vede sgretolarsi una dietro l’altra le sue certezze nello scacchiere mondiale più turbolento. E non sa come affrontare il terremoto globale innescato dalla rapida avanzata dell’Is, lo Stato Islamico.Tutta l’armata occidentale sta facendo i bagagli. Entro fine anno il grosso delle truppe Nato se ne andrà: avamposti e comandi vengono sgombrati, cedendo le posizioni all’esercito afghano.
I piani per il futuro prossimo però sono tutti in discussione, in uno scenario che assomiglia sempre più a un labirinto. C’è il rischio che il vuoto di potere a Kabul trasformi la ritirata in fuga. E c’è chi al Pentagono teme di assistere al replay di quanto appena accaduto in Iraq, con le brigate islamiche che hanno trionfato sfruttando gli scontri tra fazioni etniche e l’assenza di forze americane sul campo. Un vero dilemma, che ci tocca molto da vicino. Perché anche l’Italia deve decidere in fretta cosa fare. Il programma della Nato era chiaro. Portare via la maggioranza degli uomini e dei mezzi, mantenendo nel Paese un contingente limitato con un duplice scopo. Proseguire nell’addestramento dei battaglioni afghani, facendo sentire il sostegno concreto degli occidentali. E garantire un nucleo consistente di aerei e di commandos, per intervenire nei momenti di crisi e tenere il fiato sul collo alla guerriglia talebana. A giugno Obama aveva annunciato che sarebbero rimasti 9.800 militari statunitensi: 8 mila istruttori per aiutare l’esercito locale, 1.800 incursori per dare la caccia agli insorti. Gli alleati atlantici avrebbero dovuto schierarne altri 4 mila. Finora solo Roma e Berlino hanno risposto all’appello, offrendone ottocento ciascuno: gli altri partner sembrano disposti solo a un presidio simbolico. In pratica, dai centomila soldati del 2010 si sarebbe scesi a circa 12 mila. Ma la presenza del contingente atlantico deve essere ratificata dal governo di Kabul, che ancora non c’è. Le lunghe elezioni sono state contestate, lasciando i due candidati sul piede di guerra. Senza un trattato che garantisca l’immunità, i militari occidentali possono venire incriminati per ogni civile ucciso, per qualunque vittima dei “danni collaterali”. E dopo la crescente ostilità verso le truppe straniere mostrata dal presidente uscente Karzai, nessuno è disposto a fidarsi delle promesse. Così ogni nazione sta portando avanti il ritiro con un duplice piano. L’Italia ad esempio in due anni ha ridotto le forze da 4.200 soldati a 1.411: entro Natale saranno rimpatriati 1.034 mezzi e 11.700 tonnellate di materiali. Poi da gennaio è previsto solo un battaglione di 800 uomini concentrato sulla base di Herat. Si tratterà in massima parte di istruttori e specialisti per spiegare alle reclute afghane come combattere e come mantenere efficienti i veicoli. La reale natura di quest’operazione non è ancora chiara. Finora non ci siamo limitati ad addestrare le truppe locali nelle caserme, ma le abbiamo anche accompagnate al fronte con squadre di “mentor”: un’attività che potrebbe rivelarsi troppo pericolosa nei prossimi mesi. Ci saranno poi un centinaio di teste di cuoio: un nucleo agli ordini del nostro comando, un altro inquadrato nella Task Force 45 alle dipendenze dirette dal quartiere generale alleato. Per la loro protezione, oltre ad alcuni mortai pesanti da 120 millimetri, resterà un plotone di veicoli corazzati, probabilmente i cingolati Dardo. Gli ultimi a partire saranno quattro elicotteri da battaglia Mangusta, che sono diventati l’angelo custode del contingente tricolore. In sette anni sono stati in azione per circa 11 mila ore, risolvendo con i cannoni a tiro rapido e missili tutte le situazioni più drammatiche: lo Stato maggiore ha dichiarato che la «percentuale di successo è stata del 100 per cento». Se non ci fosse un accordo con Kabul, anche questi ottocento potrebbero prendere la strada di casa, concludendo definitivamente la spedizione italiana entro Pasqua o al massimo entro l’estate. Una prospettiva che non pare dispiacere al governo Renzi, alla luce dei costi altissimi che comporta lo schieramento a Herat: bisogna trasportare tutto per via aerea, dalle munizioni alle bottiglie d’acqua. Il ministro Roberta Pinotti ha ribadito poi la volontà di concentrare il nostro impegno in territori più vicini al nostro interesse nazionale, un’area che le bozze preliminari del nuovo Libro Bianco della Difesa individuano nel “Mediterraneo allargato” e dove non mancano zone di crisi che potrebbero richiedere a breve interventi armati, dal Libano alla Libia. Agli americani invece il ritiro totale dall’Afghanistan appare come un incubo. Ci sono postazioni strategiche a cui il Pentagono non vuole rinunciare. Come la grande base aerea di Bagram, a meno di un’ora di volo dalla Cina e dalle ex Repubbliche asiatiche dell’Urss. O come Shindand, l’aeroporto-fortezza costruito a ridosso della frontiera iraniana dove operano i droni-spia della Cia. Ma soprattutto c’è il terrore che la crisi di potere a Kabul apra le porte a una rapida riconquista dei talebani, trasformando ampie regioni del Paese in un altro califfato. Già oggi l’esercito di Kabul non sembra in grado di fronteggiare la minaccia. Gran parte dei 641 miliardi di dollari spesi dagli Usa per il conflitto afghano sono stati destinati alla creazione di forze armate locali efficienti, ma l’obiettivo resta lontano. La quantità è quella prevista – 195 mila soldati – ma la qualità rimane bassa. In questi anni di guerra gli uomini si sono mostrati coraggiosi, tenendo fede alla tradizione guerriera: la punta di diamante sono 12 mila commandos, ben equipaggiati e molto motivati. Pochi reparti però sanno manovrare su larga scala, coordinando unità mobili e artiglieria; la manutenzione dei veicoli è scarsa; le diserzioni frequenti. L’aviazione è allo stato embrionale, con pochissimi aerei e soprattutto pochi elicotteri, fondamentali in un Paese praticamente senza strade. Le forze armate sono una delle poche istituzioni multietniche, che il sostegno della Nato ha finora reso autonome dai potentati locali. Invece i 150 mila uomini della polizia nazionale – chiamata Ansf – fanno riferimento ai vari signori della guerra e governatori regionali. La loro fedeltà è sempre stata guardata con diffidenza e i patti sotterranei con i talebani non sono rari. I fondamentalisti negli ultimi tre anni sono riusciti a infiltrare uomini dovunque, conducendo attacchi micidiali. Ad agosto un soldato afghano ha fatto irruzione durante un vertice del comando alleato, uccidendo un generale americano – l’ufficiale più alto in grado caduto dall’11 settembre 2001 – e ferendo altri quattordici graduati occidentali. Negli ultimi mesi i talebani non sembrano avere cercato di sfruttare il ritiro per passare all’offensiva. Calano nelle valli dove non ci sono più pattuglie americane o inglesi, si fanno vedere nei villaggi senza però assaltare città o basi abbandonate dalla Nato. In parte è un effetto delle trattative avviate dalle autorità di Kabul con alcuni dei capi fondamentalisti meno radicali. Ma i guerriglieri paiono soprattutto studiare la situazione in attesa del momento migliore per colpire. Mai come oggi l’autorità centrale è apparsa fragile. Le due tornate elettorali si sono chiuse senza un presidente. I due candidati – Abdullah Abdullah, un collaboratore del comandante Massud ed ex ministro degli Esteri, e Ashraf Ghani, un professore formato negli States ed ex responsabile delle Finanze – si ritengono entrambi vincitori. La contesa sta riaprendo le tensioni etniche, con i tajiki del Nord raccolti intorno ad Abdullah e la maggioranza pashtun del Sud che sostiene Ghani. La partita è cominciata già da mesi, per conquistare posizioni chiave nei palazzi del potere. E in questi giorni il tentativo di Ghani, convinto di arrivare presto alla nomina formale, per la creazione di un governo d’unità nazionale si scontra con la diffidenza tajika. «Non può trattare da posizioni di superiorità, pretendiamo di essere considerati come suoi pari», ha dichiarato l’ex capo dei servizi segreti Amrullah Saleh, uno dei leader del partito di Abdullah. La guerra civile è l’incubo numero uno per il Pentagono. Fu proprio sfruttando gli scontri tra fazioni che terrorizzavano la popolazione che nel 1994 i talebani comparsi dal nulla riuscirono a conquistare il Paese in soli due anni: una velocità che ricorda il successo dell’Is nella Siria dilaniata dalle bombe e nell’Iraq diviso dall’odio tra sunniti e sciiti. E oggi alcuni famigerati protagonisti di quella faida tribale stanno tornando a farsi sentire, dal generale Dostum a Gulbuddin Hekmatyar, che si lascia tentare dai proclami del Califfato. «Stiamo ripetendo lo stesso errore commesso quando siamo andati via dall’Iraq», ha detto il senatore John McCain. Per questo molti a Washington cominciano a chiedere che il ritiro venga rallentato. Il generale Joseph Dunford, comandante delle forze Nato, ha spiegato che «non sarebbe un problema» aumentare fino a 12 mila il numero dei soldati americani destinati a rimanere il prossimo anno. Un’opzione già sottoposta a Obama, assieme all’eventualità di posticipare l’uscita definitiva, prevista per il 2017. La Casa Bianca è incerta. C’è il timore di finire impantanati in una trappola, nel fuoco incrociato del tutti contro tutti, con il rischio di essere obbligati poi all’escalation: uno scenario che riporta alla mente il Vietnam. Ma è forte anche la paura di assistere impotenti a un’insurrezione generale talebana. In questo clima ad alta tensione, sulla collina che domina Kabul da alcuni giorni sventola una gigantesca bandiera con i colori nazionali lunga più di trenta metri: non è una manifestazione di orgoglio, ma un dono del governo indiano. Un tentativo di trasmettere fiducia non condiviso dalle altre potenze della regione. Il Pakistan ha appena cominciato la costruzione di un muro sul confine: una linea di reticolati lunga quattrocento chilometri, per evitare che un futuro trionfo talebano superi le frontiere.