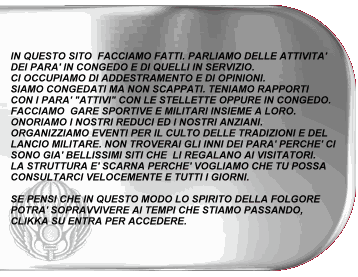Pubblicato il 11/11/2013
LE MOND DIPLOMATIQUE del 11.11.13 Immagini pulite, conflitti sporchi La comunicazione militare in tempo di guerra

LE MOND DIPLOMATIQUE del 11.11.13
Immagini pulite, conflitti sporchi
La comunicazione militare in tempo di guerraLibia, Mali, Siria: la comunicazione dei militari in tempo di guerra si è professionalizzata. Anziché tacere, secondo gli antichi costumi, l’esercito preferisce tergiversare. La parola d’ordine è non mentire, per evitare le accuse di manipolazione e disinformazione. I militari vogliono stabilire le loro regole del gioco.…
un’inchiesta di PHILIPPE LEYMARIE *
«Guerra a porte chiuse… senza immagini… virtuale… senza nemici…senza vittime… senza prigionieri…»: le prime settimane del conflitto in Mali, nel gennaio 2013, sono state sconcertanti per i media e per l’opinione pubblica.
Si sarebbe detto che l’esercito, la Grande Muette (in passato era definito Grande muto perché non doveva esprimersi su questioni politiche, ndt) avesse costruito una comunicazione semi-ermetica la quale, contro i «jihadisti», attribuiva alla Francia un ruolo centrale: quello di «madre vincitrice», dai mezzi copiosi e rodati, dalla tattica perfetta, a cui niente può resistere.
Sarebbe anche riuscita a gestire la suscettibilità dell’esercito maliano, conferendo al presidente François Hollande l’occasione di una missione trionfale, simile a quella dell’imperator Nicolas Sarkozy nella sua avventura libica.
A metà gennaio 2013, nelle prime ore dell’intervento, un dispiegamento di 150 giornalisti si ritrovavano bloccati a Bamako, la capitale, o più a nord, nelle retrovie di un fronte in ritirata. In un primo momento, ci racconta il colonnello Thierry Burkhard, portavoce dello stato maggiore dell’esercito, cercarono «di girare immagini che non esistevano, vedere combattimenti che non avevano luogo».
Era impossibile farli ragionare: «Tutti volevano salire a bordo del primo Vab [Veicolo blindato di prima linea] della colonna». Ma non si poteva mostrare loro che rotazioni di aerei, o arrivi e partenze di soldati – come durante l’operazione «Tempesta del deserto» nel 1991 nel Golfo. (1) Due mesi dopo, nel marzo 2013, durante la prima settimana di combattimenti nelle montagne dell’Adrar degli Ifoghas, nell’estremo nord-est del paese, i giornalisti volevano vedere tutto anche lì: prigionieri, cadaveri di «jihadisti». Ancora una volta, «immagini che non esistevano», afferma il colonnello Burkhard.Secondo lui, filmare la guerra non è semplice: «Non ne viene fuori né la battaglia di Stalingrado né Black Hawk abbattuto (2)», prorompe. Per tutto il conflitto, questo ufficiale abituato alle relazioni con i media ha dovuto gestire la concorrenza commerciale fra le grandi catene televisive, «a volte a detrimento dell’informazione», per esempio quando una di queste ha preferito chiedere la cancellazione di un’intera missione di giornalisti a bordo di un veicolo militare piuttosto che vedere la sua concorrente partire da sola. Ma, constata Jean-Marc Tanguy sul suo blog Le Mamouth, «la versione che predomina [tra i giornalisti a proposito del conflitto in Mali] è quella di un passo indietro rispetto alle pratiche d’apertura osservate fino a quel momento, per esempio in Afghanistan (3)».
La maggior parte degli inviati speciali in Mali erano giovani non avvezzi alle tecniche militari e alle realtà africane, rincara Pierre Bayle, direttore della Delegazione per l’informazione e la comunicazione della difesa (Dicod). Secondo lui, questi neofiti si aspettavano «battaglia, fiamme, esplosioni»: ma è stato possibile offrir loro solo la logistica. La guerra asimmetrica è una «guerra a distanza, poco visiva». Man mano che avanzavano i comandanti delle forze speciali, prima linea dell’offensiva francese, i «jihadisti» scappavano verso i confini del paese: non c’erano quindi combattimenti da mostrare.
E, anche se ci fossero stati, le forze speciali sono coperte dal segreto militare: l’esercito protegge i movimenti e i metodi d’azione dei soldati che «entrano per primi» su un terreno di combattimento. La legge proibisce in particolare di rivelare la loro identità. «È con i soldati chadiani che i giornalisti avrebbero potuto riprendere delle belle immagini, in seguito, nell’Adrar!», fa notare Bayle.
E così, le troupe di cameramen dell’esercito, «Famas (4) in spalla», erano le più produttive. Conquistare i cuori e le menti «I giornalisti credono che viaggiare su degli aerei militari sia un diritto», si lamenta il capo della cellula di comunicazione dello Stato maggiore, soprannominato dai suoi commilitoni «Air Burkhard», per via delle tante richieste di imbarco di giornalisti e tecnici sui Transall che riceve. Ma il colonnello è contento di aver potuto «imbucare» anche media meno importanti, come la catena France 24, che può essere ricevuta da una parte dei telespettatori maliani. In due mesi, ha ricevuto all’interno delle forze armate quattrocento giornalisti di 212 media. E soprattutto, l’esercito francese può fregiarsi di avere, grazie alle sue troupe di reporter, fornito le immagini che tanto mancavano agli inviati speciali: 120 video e 500 fotografie senza diritti d’autore, «a volte utilizzate senza menzionare la loro origine militare», si stupisce Burkhard.
«Comprendendo che i giornalisti non sono mai contenti di quello che gli si mostra», egli stima che la copertura mediatica fosse quindi più facile in Afghanistan, con un percorso molto organizzato, poiché l’opzione embedded (letteralmente: «nello stesso letto», cioè integrata nelle unità militari) era la sola possibile. Un vantaggio per i comunicatori, poiché gli è più facile sensibilizzare i giornalisti all’imperiosa «sec ops», sicurezza delle operazioni. Ma anche vincoli maggiori in termini di trasporto, procedure, protezione: la presenza di una troupe televisiva in un Vab richiede di rinunciare a tre soldati. «Se si va su questa china, non si fa più guerra, ma trasporto!», scherza Burkhard. Hervé Ghesquière, grande reporter di France 3, incarna coloro ai quali non basta imbarcarsi al fianco di uno dei belligeranti. Dopo un aver trascorso del tempo, negoziato con le autorità, in una base avanzata dei militari francesi e afghani alla fine del 2009, stanco di essere sempre accompagnato dai suoi «angeli custodi», aveva voluto raccogliere il punto di vista degli abitanti dei villaggi nella valle di Kapisa. Sperava così di fare il punto sull’impegno francese in Afghanistan per il programma «Pièces à conviction», un anno dopo l’imboscata sanguinosa d’Uzbin, a una cinquantina di chilometri a nord-est di Kabul, che il 18 e 19 agosto 2008 aveva causato dieci morti e ventuno feriti tra i soldati francesi.
Con il cameraman Stéphane Taponier, Ghesquière è stato rapito e tenuto in ostaggio per 547 giorni (5). Considerato dai dirigenti politici e militari dell’epoca come «indisciplinato», «imprudente», «indifferente agli avvertimenti», «trasgressore dei divieti», accusato di aver «cercato lo scoop ad ogni costo (6)», «fatto correre rischi ad alcuni militari» ed essere costato caro alla Repubblica (7), cerca una spiegazione di tipo strategico. La sua avventura diventa un danno collaterale, e lui il capro espiatorio: «Il nostro errore è stato di farci rapire dai talebani su una strada importante situata tra due basi francesi, Tagab e Tora. Queste basi avevano come missione, proprio di mettere in sicurezza quest’asse essenziale, detto “Vermont”, che collega l’est dell’Afghanistan al Pakistan». In seguito, il giornalista di France 3 parla di «un terribile insuccesso della missione francese», che spiegherebbe la polemica suscitata dal suo rapimento, mentre si avviava il dibattito che ha portato al ritiro delle truppe francesi di combattimento fuori dall’Afghanistan, due anni prima di quelle della coalizione. «La vostra imprudenza ha rovinato il lavoro nella regione», ha rimproverato in seguito a Ghesquière il generale Jean-Louis Georgelin, che era capo di stato-maggiore dell’esercito durante il rapimento dei due uomini. «Ci avete obbligati ad adottare una posizione aggressiva che ci ha complicato il compito nella nostra missione di “conquista dei cuori e delle menti”.» A capo di una ventina di ufficiali addetti stampa dell’esercito francese a Kabul tra il settembre 2009 e l’aprile 2010, il luogotenente colonnello Jacky Fouquereau ha visto passare circa 200 giornalisti, tra cui Ghesquière e Taponier.
Per tutti era stabilito, all’inizio del loro soggiorno, un briefing di sicurezza: zone proibite, zone dove la libertà di movimento è limitata, comportamento da adottare con gli impiegati e i soldati afghani, ecc. Si vedevano in seguito attribuire un ufficiale addetto stampa incaricato della loro sicurezza diretta, e della gestione dei rapporti con l’insieme delle truppe. Il luogotenente-colonnello ricorda in particolare di uno scontro con giornalisti statunitensi i quali volevano entrare in un mercato ritenuto poco sicuro, cosa che non poteva essere organizzata se non con un complesso dispositivo, sia per proteggerli sia per rassicurare la popolazione. In generale, la comunicazione operativa, che è per definizione una comunicazione di crisi, impone una serie di condizioni. «Non è un reality: il colonnello incaricato di un’unità, di un’operazione, non ha necessariamente voglia di avere il microfono sotto il naso mentre agisce…», osserva Fourquereau. Afferma di aver avvertito la troupe di France 3 che la sua avventura era una «missione impossibile» e di aver dichiarato il proprio stupore – anche presso la direzione del canale televisivo e presso i superiori gerarchici al ministero della difesa – per questo cambiamento di contesto in un’inchiesta che doveva concentrarsi sul clima nel contingente francese a un anno dal caso Uzbin. Passando ad altro, i giornalisti furono rapiti nella regione di Tagab il 29 dicembre 2009.
I giorni seguenti, il fronte della valle della Kapisa era stato neutralizzato, il piano della campagna francese nella Forza internazionale di assistenza e sicurezza (Fias) rivista al ribasso, i giornalisti in zona rimpatriati, e ogni comunicazione nell’area sospesa per qualche mese. Da allora, anche se i rapimenti nei teatri di operazioni resta un’ossessione, l’episodio Ghesquière non si è ripetuto. Quando gli spieghiamo che un’informazione è sensibile (il nome di un villaggio, una via seguita…), «i giornalisti accettano in generale questa preoccupazione per la discrezione», sottolinea il colonnello Burkhard. Capiscono di essere, per i loro collegamenti e resoconti in tempo reale, con i telefoni satellitari, i blog, i social network (si legga il riquadro), la migliore se non la sola fonte d’informazione di avversari che non dispongono di mezzi sofisticati. «Gli amici di fronte, nelle grotte, combattono anche su Internet. Captano delle indicazioni», ricorda Bayle. Ma per questo ex professionista (8), i diritti e i doveri del giornalista sono proprio andare a cercare delle notizie. Cita Yves Debay, «soldato dell’informazione morto in prima linea» nel gennaio 2013 in Siria, come l’esempio tipico di corrispondente di guerra wildcat («testa calda») Ftp (fotografo cecchino) (9).
Ed è contrariato dalla «svolta dell’11 settembre 2001», a partire dalla quale «il giornalista occidentale è apparso come il nemico». Da allora, è diventato più difficile coprire un conflitto da ambo i lati, che sia al tempo della prima guerra del Golfo, dei Balcani, Israele-Palestina o nelle grandi guerre civili del Corno d’Africa. Oltre ad accrescere i rischi di manipolazione, questo seguire la guerra «da una sola parte» è stato spesso accompagnato da un inasprimento dell’inquadramento del giornalista, appelli ripetuti all’autocensura e addirittura divieto d’accesso ad alcune fonti o ad alcuni luoghi. Questo non è stato tuttavia il caso del Mali: anche se i giornalisti non hanno ottenuto le immagini che desideravano, hanno goduto di un’ampia autonomia. Non sono stati portati fino a Bamako a spese della Repubblica, come in altri conflitti: le operazioni di comunicazione «viaggi inclusi» sono diventate l’eccezione in ragione delle restrizioni di bilancio. «Il nemico principale non si chiama talebano, ma Rgpp (10)!», ironizza il direttore della Dicod. L’imbarco dei media nelle forze francesi significa d’altronde, secondo Patricia Allémonière, capo redattore al servizio esteri-difesa di Tf1 e di Lci, avere in permanenza «una mano sulla spalla»: i professionisti sono accompagnati e inquadrati da un esercito che si cura prima di tutto di lanciare un messaggio positivo per suscitare l’appoggio dell’opinione pubblica in Francia. Allo stesso modo, questa habitué della copertura dei conflitti trova difficile da sopportare la sollecitudine dei militari francesi che, in nome di «nessun morto», vogliono a ogni costo evitare perdite tra i giornalisti, a rischio, secondo lei, di un eccesso di precauzioni (11). «È importante che la guerra sia mostrata o che sia vinta?», domanda il generale Vincent Desportes, ex comandante dell’insegnamento superiore militare. Insiste sulla dimensione psicologica del conflitto: l’avversario, per esempio, avrà interesse a insistere sull’estensione dei «danni collaterali», o a mettere l’accento su una manifestazione di locali a favore di un gruppo ribelle. Poiché la battaglia si svolgeva anche sul fronte della comunicazione, «bisognava poter mettere davanti i soldati maliani con la loro bandiera» durante l’avanzata dei soldati francesi verso Gao e Timbuctù, nel nord del Mali, anche se non avevano avuto nessun ruolo nell’offensiva-lampo, per proteggere l’opinione pubblica e l’esercito maliano. Prova, secondo l’ufficiale generale, che «le immagini del momento possono impedire la realizzazione finale di un’operazione». E che, «se tutto, in linea di principio, può essere visto e trasmesso, i nostri concittadini non hanno sempre la distanza necessaria per giudicarlo». Ritiene quindi normale mantenere un certo «controllo dell’immagine» (12). Il fatto di non divulgare le informazioni contraddice tuttavia uno degli obiettivi essenziali della comunicazione operativa: convincere l’opinione pubblica della legittimità dell’intervento, e spiegare come i soldati procedono sul terreno per ottenere gli obiettivi prefissati. «Oltre alla legittimità che un sostegno forte conferisce alle nostre operazioni, si tratta anche di un fattore determinante per il morale dei militari e delle loro famiglie», commenta Burkhard (13). Ma fino a che punto, per esempio, mostrare i morti? Il Consiglio superiore dell’audio-visivo (Csa), che, lo scorso gennaio, aveva raccomandato ai media di non diffondere immagini di cadaveri in Mali, si era attirato una replica immediata di Reporters sans frontières: «A nome della protezione dei giovani telespettatori, il Csa non protegge la comunicazione ufficiale di un’operazione militare? È aberrante mostrare della guerra nient’altro che dei tramonti su carri armati scintillanti. Il pubblico non può essere soddisfatto delle informazioni raccolte sotto il controllo militare o direttamente trasmesse dall’esercito». «In guerra, ci sono immagini pulite e immagini sporche», titolava il sito Arrêt sur images il 29 agosto 2008, qualche giorno dopo l’imboscata d’Uzbin. Pierre Babey, giornalista di France 3, vi aveva ricordato le consegne in vigore all’epoca sul terreno: niente foto o video di cadaveri, nessuna immagine dell’imboscata di Uzbin; nessuna immagine di bare rimpatriate in aereo. Tra l’altro, in Afghanistan, come durante la guerra d’Algeria o la guerra del Golfo, i reportage sul campo avversario erano rari, da qui la «percezione di una supremazia delle immagini occidentali». Tramonto su carri armati scintillanti Il fotografo tedesco Horst Faas ha coperto la guerra del Vietnam dal 1962 al 1974, diretto il servizio fotografico dell’agenzia Associated Press a Saigon e pubblicato delle foto di soldati morenti o di civili vietnamiti terrorizzati dai bombardamenti. Secondo lui, era possibile, all’epoca, pubblicare immagini di morti se la famiglia veniva avvertita. Da allora, la guerra è diventata «una burocrazia. Ci vogliono autorizzazioni per ogni cosa». Come riassume la giornalista Claire Guillot che aveva parlato con lui, «l’accesso al teatro delle operazioni è limitato e, di conseguenza, i fotografi mostrano soprattutto il prima e dopo dei combattimenti. Riguardo alla censura, l’amministrazione americana ha fissato “delle regole strane”, che proibiscono di fare foto a un ferito senza la sua autorizzazione». E Faas si domanda: «Si chiede forse a questa gente l’autorizzazione prima di bombardarli?» (14). I militari americani – come, in Europa, i loro colleghi tedeschi – sono diventati maestri in «psy ops»: tecniche d’influenza che hanno fatto adottare all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (Nato), in particolare in Afghanistan. All’indomani degli attentati dell’11 settembre 2001, il Pentagono ha creato in gran segreto l’Office of Strategic Influence (Osi), un’agenzia di propaganda incaricata di «modellare le opinioni pubbliche a livello planetario con un’intossicazione massiccia di media, circoli di riflessione influenti e gruppi di pressione (15)». L’Osi è stato sostituito nel 2002 dall’Office of Special Plans (Osp), diventato in seguito, nel 2003, Northern Gulf Affairs Office, ufficio d’analisi e di comunicazione sulla situazione in Medio oriente che aveva come obiettivo principale di «diffondere informazioni, vere o inventate, sulle armi di distruzione di massa, per preparare l’intervento americano in Iraq». Questo ufficio si era appoggiato sulla società privata di relazioni pubbliche Rendon Group, specializzata in dossier di informazioni, che preparava strategie di influenza e classificava i giornalisti su una scala di «gradi di fiducia». In passato molto schierati a destra, i militari francesi hanno allo stesso modo saputo condurre una guerra dell’informazione (16) al tempo dei grandi conflitti coloniali degli anni ’50, con il pretesto di lotta contro il comunismo. In Indocina, di fronte a nazionalisti che sapevano compensare il loro handicap militare con il ricorso all’arma ideologica, un Ufficio della guerra psicologica era incaricato di studiare e di dirigere ogni forma d’azione diversa dal combattimento suscettibile «di attaccare il morale del nemico e la sua volontà di combattere», con propaganda, censura, finti riallineamenti, ecc. Queste tecniche furono perfezionate e generalizzate in Algeria, in particolare con la creazione di un Centro d’istruzione, di pacificazione e di contro-guerriglia che spiegava i mezzi per demoralizzare, convincere e riallineare il nemico. Il Gruppo di indicazione e sfruttamento (Gre) orchestrava manovre di disinformazione destinate al Fronte di liberazione nazionale (Fln) e ai suoi sostenitori. Si ricordano anche imprese più recenti di manipolazione: la finta fossa comune di Timisoara, in Romania, prima della caduta di Nicolae Ceausescu nel 1989, o lo stretto controllo delle immagini e delle parole da parte degli stati maggiori alleati e di specialisti in comunicazione al tempo della guerra contro l’Iraq del 1990-1991; e infine, sempre in Iraq, l’invasione del 2003, con «fabbricazione del nemico (17)» alla fine. La menzogna del presidente George W. Bush sulla presenza di armi di distruzione di massa, per giustificare l’invasione del paese, così come lo snaturamento nel 2011 della risoluzione dell’Onu che autorizzava l’imposizione di una No-fly zone, contribuiscono a spiegare perché la Francia e gli Stati uniti hanno dovuto in definitiva rinunciare a lanciare la loro operazione punitiva contro il regime siriano.
note:
* Giornalista, autore del blog Defénse en ligne, http://blog.mondediplo.net
(1) Si legga «Mali, la victoire en chantat» e «Victime collatérale», Difesa in linea, rispettivamente del primo febbraio 2013 e del primo settembre 2011, http://blog.mondediplo.net
(2) Film americano di Ridley Scott (2001), ispirato all’intervento in Somalia dell’esercito degli Stati uniti nel 1993.
(3) Jean-Marc Tanguy, «Le com’ de Serval devant la mission d’information», 2 luglio 2013, http://lemamouth.blogspot.fr
(4) Fucile d’assalto in dotazione all’esercito francese.
(5) Hervé Ghesquière, 547 giorni, Albin Michel, Parigi, 2012.
(6) Claude Guéant, ministro dell’interno, 17 gennaio 2010.
(7) Il 21 febbraio 2010, il generale Jean-Louis Georgelin, capo di stato dell’esercito, valutava già pari a 10 milioni di euro in due mesi le spese causate da questo rapimento, con la smobilitazione di quattrocento soldati e di una cinquantina di agenti della Direzione generale della sicurezza esterna (Dgse).
(8) Ex giornalista, Bayle ha in particolare diretto la lettera Ttu, in seguito la comunicazione del gruppo European Aeronautic Defence and Space (Eads).
(9) O ancora «Fuck the pool», allusione ai fotografi che preferirono accedere liberamente alle zone di conflitto piuttosto che imbarcarsi nelle combat pools organizzate dai comunicatori militari.
(10) La revisione generale delle politiche pubbliche (Rgpp) è stata lanciata nel 2007 con lo scopo di ridurre l’indebitamento dello Stato, e perseguita secondo modalità che sono cambiate nel corso degli anni.
(11) Dibattito sul mestiere di reporter di guerra organizzato il 17 febbraio 2013 a Parigi da Libération, «La guerre d’un seul côté», 18 febbraio 2013, http://pierrebayle.typepad.com
(12) Incontro con membri dell’Associazione dei giornalisti di guerra, 12 febbraio 2013.
(13) Cfr. «Les impératifs de la communication opérationnelle», Armées d’aujourd’hui, n°379, Parigi, aprile 2013.
(14) Claire Guillot, Le Monde, 6 settembre 2008.
(15) Cfr. Michel Klen, Les Ravages de la désinformation d’hier à aujourd’hui, Favre, Lausanne, 2013.
(16) Cfr. Paul e Marie-Catherine Villatoux, La République et son armée face au «péril subversif». Guerre et action psychologiques, 1945-1960, les Indes savantes, Parigi, 2005.
(17) Cfr. Pierre Conesa, La Fabrication de l’ennemi, Robert Lafford, PaLeggi anche