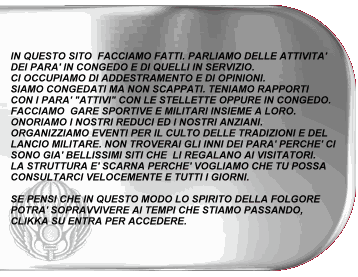Pubblicato il 03/07/2014
LO STRESS POST TRAUMATICO DEI SOLDATI ITALIANI: RABBIA PER LE REGOLE DI INGAGGIO ITALIANE

L’AVVENIRE del 3 Lugluio 2014
«Dal fronte si torna arrabbiati. Con se stessi»
LAURA SILVIA BATTAGLIA
Possibili menomazioni fisiche e disturbi da stress post-traumatico: è il prezzo che spesso pagano i militari Nato impegnati nelle missioni all’estero.
Ma se per le prime la riabilitazione si impone come necessaria, per le seconde non sempre si interviene. Sia perché gli stessi militari non ammettono di soffrire di questa patologia o non sono in grado di individuarla, sia perché c’è il timore di non essere reintegrati. Negli Stati Uniti, l’ annus horribilis per i veterani è stato il 2011 con 3,072 casi di PTSD su militari non al fronte e ben 15.831 casi di unità al fronte.
In Italia il problema si fa evidente soprattutto con la missione Isaf in Afghanistan: 10 morti nel 2011, 8 nel 2012.«La sanità dello Stato Maggiore si attiva a seconda dei traumi riportati dal militare – rende noto il colonnello Riccardo Cristoni, ufficiale di pubblica informazione – . Si sceglie, in ogni caso, di assistere chi ne fa richiesta con un ufficiale psicologo militare». Come il capitano Isabella Lo Castro: «Seguiamo i militari prima, durante e dopo la missione, in base al loro “ciclo emotivo” d’impiego e le differenti tipologie di stress a cui si va incontro. Sul prima lo psicologo lavora in piccoli gruppi, sul durante lavora singolarmente, sul post lo fa ancora in gruppo per “rinarrare” la storia del vissuto della brigata e integrarla con quella personale, come strumento di prevenzione e resilienza».
Il problema, però, è spesso qui: può essere difficile che una terapia psicologica con un ufficiale militare abbia gli stessi effetti che con uno psicologo estraneo all’Arma.Il capitano Lo Castro lo esclude in base alla sua esperienza; anzi, dopo Nassirja, dove era presente, sostiene che la confidenza aumenta con il senso di appartenenza. Non è dello stesso avviso la dottoressa A- melia Alborghetti della Fondazione Don Gnocchi Onlus che ha attivato una ricerca sperimentale per la valutazione del PT- SD su 22 militari che hanno operato in zone di guerra. «I militari da me “intervistati”, quasi tutti della brigata Folgore, mostrano sindrome da PTSD con un valore medio corrispondente a “grave”: ciò significa che siamo ancora lontani dai dati che ci restituiscono le statistiche statunitensi». I militari italiani, in ambito Nato eseguono missioni meno “combat” rispetto ai colleghi americani ma, soprattutto, rimangono in teatro operativo per una durata massima di sei mesi (e non di 14 come gli americani).
Ma la ricerca mette in evidenza un dato totalmente contrastante rispetto agli omologhi d’oltreoceano. «Il PTSD non proietta i militari italiani verso la depressione ma piuttosto verso l’iperreattività e le risposte aggressive», sottolinea la Alborghetti. I motivi sono sia la giovane età ma anche e soprattutto una forma di arrabbiatura contro se stessi per non avere saputo e voluto reagire di fronte a situazioni che li hanno posti in pericolo o che hanno causato la morte di un commilitone.
Molti dei “pazienti” puntano il dito contro le regole di ingaggio che gli italiani seguono e che impediscono di rispondere al fuoco nemico quando le armi del nemico non sono evidenti. Per una fonte dello Stato Maggiore con lunga esperienza al fronte e il grado di generale «da quando i conflitti son diventati trasversali e il nemico può essere anche un bambino imbottito di esplosivo, i nervi son messi a dura prova. Ma se scegliamo di essere militari, sappiamo di essere pagati per soffrire».Leggi anche