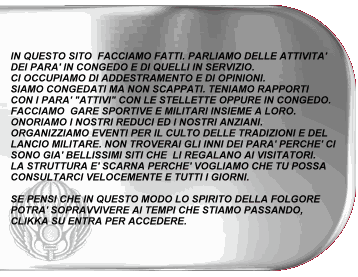Pubblicato il 16/10/2014
RASSEGNA STAMPA
L’ARENA DI VERONA del 16 OTTOBRE 2014
Ha 88 anni (89 il 21 novembre), ma se non avesse problemi alle ginocchia si lancerebbe con il paracadute anche subito. «Ogni tanto», confessa, «telefono all’aeroporto di Boscomantico e chiedo informazioni su lanci e orari».
Sogna per qualche minuto e poi ci mette una pietra sopra per un altro anno. «I miei figli non vogliono», spiega, «perché se in fase di atterraggio si alzasse il vento e cadessi male, addio gambe. Così mi accontento di guardare gli aerei e i paracadutisti alle manifestazione o in tivù».
Il pensiero, però, non la lascia mai. Il paracadutismo è stato il primo amore della sua vita. Elda Garzon, veronese, è stata la prima donna italiana a lanciarsi, finendo sui giornali nazionali, che avevano battezzata lei e le sue colleghe «amazzoni dell’aria», «ardimentose» e «audaci». Poi lei si era ulteriormente distinta per essere «una delle due sole donne italiane abilitate ai lanci pericolosi ad alta quota». «Ho fatto il primo lancio femminile in Italia autorizzato dal Ministero dell’Aeronautica: era il 1952», racconta. «A Gardone Riviera c’era una manifestazione nazionale di paracadutisti. Ci si lanciava nel lago di Garda. Sono stata scelta con la mia amica Rosanna Lancerotto, anche lei veronese: siamo decollate da Ghedi, prima mi sono buttata io e poi lei. È stato bellissimo».
Peccato, però, non sapesse nuotare. «Ci hanno fatto indossare il salvagente che dovevamo gonfiare una volta aperto il paracadute. Poi dovevamo mettere il tubicino nei passanti, stando attente a non far uscire l’aria. Ricordo che un paracadutista, vedendomi un po’ scettica, mi ha detto “Se è rotto, quando arrivi a terra vai in magazzino e te lo fai cambiare”». Ma neppure la battuta sarcastica l’ha intimorita. «Tanto era l’entusiasmo di lanciarmi che non pensavo sarei caduta nell’acqua ma solo al lancio nel vuoto», racconta raggiante. «Per fortuna è andato tutto bene e una volta recuperate dal lago abbiamo ricevuto i complimenti delle autorità». Da quel momento i lanci delle donne sono diventati un’attrazione, tanto che persino la Coca Cola ha utlizzato le prime paracadutiste, lei compresa, per la pubblicità. «Una volta per vedere i paracadutisti, negli aeroporti si pagava l’ingresso», ricorda. «Dopo il primo lancio ogni settimana, a turno, noi donne abbiamo fatto lanci in tutte le città d’Italia. All’inizio ne ho fatti sette senza emergenza con il paracadute F41, poi c’è stato l’incidente a Venezia in cui è morto Salvatore Cannarozzo (detentore del record mondiale di apertura a bassa quota, morto nel 1953 dopo un lancio, ndr) ed è arrivato il paracadute d’emergenza».
E i colleghi maschi come vi hanno accolte? «Bene», risponde. «Nessun problema: anche adesso i miei amici sono quasi tutti paracadutisti».
Elda Garzon non si è fatta mancare nulla. Si è lasciata cadere da tutte le altezze, dai 280 ai 3 mila metri e da vari aerei: Savoia Marchetti 82, Fairchild, Caproni, «119». E con diversi tipi di paracadute. «Il mio preferito era il Lisi», racconta entusiasta, «la cui velocità di caduta si poteva variare aumentando o diminuendo l’apertura della calotta con una fune che si tirava con le mani e teneva con i piedi. Veniva usato in guerra per rendersi invisibili ai nemici. Bisognava aver fatto tanti lanci per riuscire ad usarlo, come l’Irving, il paracadute ad apertura ritardata. A Fano», ricorda, «usando quest’ultimo non sono riuscita a tirare la maniglia e ho dovuto azionare il paracadute d’emergenza. Poi con tutte le mie forze sono riuscita ad azionare la maniglia e finalmente si è aperto. Quando sono atterrata tutti sono accorsi spaventati: hanno controllato il paracadute e hanno visto che la maniglia aveva il filo d’acciaio arrugginito».
Di avventure Elda ne ha vissute parecchie, ma non si è mai spaventata. A Firenze il vento l’ha spostata lontana dal campo d’atterraggio. È scesa nel cortile di una caserma e i bambini che giocavano sono entrati in casa spaventati a chiamare i genitori dopo aver visto questa strana donna volante finire in mezzo a loro. «A Bolzano, invece, il vento mi ha spostata sopra un campo di mele e sono atterrata su un albero», racconta divertita. «Non riuscivo a scendere e quando sono arrivati a prendermi con la jeep avevo in mano una grossa mela rossa. E ancora a Genova», ricorda, «mi sono lanciata in mare, partendo dall’aeroporto di Albenga, solo che il giorno prima e la notte c’era stata bufera e le onde erano alte più di due metri. Ho bevuto tanta di quell’acqua… Un colpo ero sotto e un altro in alto sulle onde, finchè finalmente sono venuti in motoscafo a recuperarmi».
Trenta lanci, le interviste, l’adrenalina. Poi nel 1956 ha girato pagina. I doveri familiari, la necessità di lavorare per mantenere anche i suoi genitori che nel frattempo si erano ammalati, il matrimonio, l’arrivo dei due figli le hanno imposto di fermarsi. «I lanci erano pagati e anche gli allenamementi, ma avevo bisogno di avere un reddito», racconta. «Smettere è stata una sofferenza: mi dispiace ancora adesso. Tanto che, per tenere in vita ciò che ho provato e vissuto, ho scritto un libretto che ho consegnato al Museo dell’aeronautica Caproni di Trento». La parola paura non è mai rientrata nel suo vocabolario. «Non ne ho mai avuta. Per me “volare” era un sogno che si avverava. Il coraggio e la voglia di rifarlo li avrei ancora». Se ora l’età le ha portato qualche acciacco, non è però riuscita a toglierle l’entusiasmo e gli occhi vivi e luminosi di quando era giovane. «Lanciarsi», spiega, «è una sensazione meravigliosa: senti l’aereo che si allontana.. nel silenzio sei padrone del cielo e vorresti non finisse mai».LA MASCOTTE UN ORSO DI PELUCHE
Ci chiama Charly ed è sempre stata la sua mascotte. È un orso di peluches poco «da coccole» e molto «scafato» (sguardo deciso e sigaretta in bocca), che le ha regalato sua madre dopo averlo munito di tuta rossa da volo, stivali neri, imbragatura con ganci e paracadute fatto con la seta di quelli veri.
«Mia madre era una sarta», racconta Elda Garzon. E di quelle brave, evidentemente. Nonostante tutti i lanci il prode Charly, imbottito con una lastra di piombo perché cadesse con una certa velocità, non si è mai rovinato. Mai uno strappo o un buco. Già perchè questa mascotte, invece di starsene in tasca o sull’aereo, seguiva la proprietaria fino in fondo. «Lo tenevo stretto nella cintura e poi quando arrivavo a 50 metri da terra, lo lasciqavo andare», racconta. «Non ho mai fatto un lancio senza di lui». Ovvero ne ha fatti due con il suo «gemello», che poi ha perso in un campo di grano a Firenze. Troppo alte le spighe per riuscire a trovarlo. «Ero disperata per averlo perso», dice. «Per fortuna mia madre ne ha subito trovato uno uguale e gli ha fatto abbigliamento e paracadute identici». Quest’ultimo però è diventato caporal maggiore. «I gradi glieli hanno disegnati i miei amici della Folgore», racconta divertita Elda. C.T.
Andavamo dai pompieri
a fare il salto dell’angelo»Spiega: «Ci spingevano la testa e le spalle fuori dall’aereo e poi chi aveva paura veniva scartato»
«Il direttore di lancio ci metteva un’imbragatura e ci accompagnava alla porta aperta del trimotore Savoia Marchetti 82, ci metteva fuori la testa e le spalle e guardava se avevamo paura per l’altezza e la velocità e poi dava il suo giudizio su chi scartare o tenere».
Paura?, chiediamo. «Mai», risponde felice Elda Garzon. «Solo la gioia di volare». Una gioia che provava fin da bambina. «Facevo sempre la parte del folletto», ricorda. «Mi mettevo su un muretto, battevo le mani e saltavo. Mi sembrava di volare». Madre di Bolzano e padre di Trento, Elda è arrivata a Verona a 9 anni. «Mio padre ero ortopedico ed è stato chiamato all’ospedale di Borgo Trento», racconta. A Verona si è ambientata subito. «Ho conosciuto Valeria, una mia coetanea che mi ha insegnato a pattinare», ricorda. «Mia madre mi portava a pattinare alla palestra Bentegodi dove veniva anche Rosanna Lancerotto (anche lei futura paracadutista, ndr). Un giorno arrivarono delle persone. Non ci dissero che erano dell’Aeroclub, ma ci chiesero se volevamo fare atletica. Accettammo. Poi apprendemmo che si trattava dell’allenamento per fare paracadutismo. Per l’addestramento andavamo dai pompieri a fare i salti dal primo piano sul telo. Poi salivamo al secondo per il salto dell’angelo. Mi piaceva molto e quando i vigili del fuoco mi vedevano dicevano sempre “Ecco, arriva la moretta». Un giorno», continua, «siamo finalmente stati portati all’aeroporto di Bergamo a fare il volo d’ambientamento. Noi ragazze eravamo sei, mentre i ragazzi erano molti di più». Intanto lei continuava ad andare in palestra a fare esercizi, in piscina e sulla sabbia a imparare a fare capriole avanti, indietro, sul fianco destro e sinistro.
«Ci allenavamo anche sulla terrazza del bar, alta due metri», racconta. «Si prendeva la rincorsa, poi salto in alto, apertura di braccia e gambe, chiusura a «chiocciola», capriola e ci si alzava. Se non si riusciva si ricominciava. Andavo a casa stanca e indolenzita, ma contenta e soddisfatta». E i suoi genitori? A loro che effetto faceva? «Sono figlia unica, quindi non è stato facile. Mio padre aveva paura, mia madre, invece, aveva grande fiducia. Entrambi però erano molto fieri e hanno conservato tutti gli articoli sui miei lanci». C.T.Leggi anche