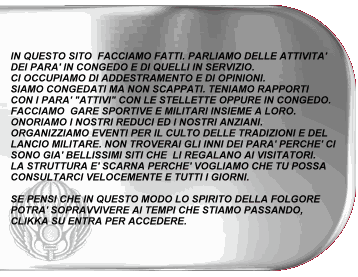Pubblicato il 31/05/2009
Il Fattore «El Alamein»- Militari oggi – Motivazione e Memoria. Vocazione o Professione

di Maurizio Manzin*
* *Maurizio Manzin è Ufficiale paracadutista di complemento in congedo
insegna Filosofia del Diritto alla Università di Trento, ed è uno dei relatori di una conferenza che venne tenuta durante la Presidenza ANPD’I del Generale Merlino, ai Cadetti di Accademia a Modena , sui Paracadutisti e sul misterioso “fattore El Alamein” di cui parla in questo articolo. Un ingrediente, quello dei Paracadutisti italiani a El Alamein, che è stato oggetto di studio nelle Accademie militari anglosassoni.
“«Dimmi un po’, perché sei venuto a fare il paracadutista?» domandavo talvolta. (…) «Una vocazione?» suggerivo. (…) Sì, vocazione era la parola giusta. Con il tempo e con la conoscenza di quegli uomini appresi a leggere assai bene nel loro animo e a discernere i motivi spirituali che li avevano condotti. E notai che in novanta casi su cento si trattava di Poesia, di rozza, primitiva, ma autentica Poesia.” (A. Bechi Luserna – P. Caccia Dominioni, I ragazzi della Folgore, Milano 1970, pp. 12.13)
“ Là dove la tecnica e la competenza sono di casa, mancano la fantasia e la poesia. Sono qualità che non fanno un guerriero, ma quando la tecnica e la competenza falliscono, tutto va a catafascio, mentre la fantasia e la poesia ti aiutano a compiere gesta che possono essere epiche. Tutto ciò è forse da dimostrare. Bene, non vorrei che questo sia considerato retorica, ma noi della Folgore, i carristi dell’Ariete con le loro scatolette di carne invece dei carri armati, i fanti della Pavia, della Brescia, della Bologna e di tutte le divisioni che hanno combattuto in Africa, gli alpini della Julia in Grecia e in Russia, lo hanno ampiamente dimostrato.” (E. Camozzi, L’inferno o giù di lì, Milano 2002, pp. 42-44)
Due cause principali hanno congiuntamente prodotto una radicale mutazione della figura del combattente: l’impegno consolidato nelle missioni multinazionali oltremare e la cessazione del servizio militare obbligatorio. A fronte dei cambiamenti introdotti è opportuna una riflessione sulla attuale natura del mestiere delle armi: professione o vocazione?
La percezione e l’autopercezione della condizione militare in Italia a partire dal secondo Dopoguerra risultano condizionate da una serie di vicende che qui riassumo in quattro punti.
Primo: le potenziali ambiguità interpretative della Carta costituzionale, nata dalla fine del totalitarismo e dal collasso dello stato liberale post-unitario. Lo stato-nazione di matrice idealistica e ottocentesca, esacerbato e infine dissolto dalla dittatura del Partito unico è stato sostituito, dopo il ’47, da uno “stato sociale di diritto” che vuol essere promotore attivo degli ideali di giustizia sociale.
Tuttavia la natura di tali ideali e i mezzi per conseguirli sono diversamente concepiti dalle componenti politico-ideologiche che concorsero alla elaborazione della Legge fondamentale. Gli articoli della nostra Costituzione mostrano l’apporto di concezioni di origine difforme e non di rado confliggente: quella marxista-leninista e gramsciana, quella socialista riformista, quella cristiano-sociale, quella azionista, quella liberaldemocratica.
Secondo: queste concezioni comportano una serie di riflessi sulla condizione militare e sul concetto di difesa nazionale. Si va da un’idea di “esercito di popolo” che esige la leva obbligatoria ed è fortemente contrario alla professionalizzazione (dove le distinzioni di rango e i privilegi di grado sono malvisti e si favorisce, piuttosto, la sindacalizzazione e le forme di collegialità “di base” antielitaria), a un’idea patriottica in cui s’insiste sulla laica “sacralità” del dovere di difesa in armi, purché rigidamente assoggettato alla volontà della rappresentanza politica istituzionale (dove ha buon gioco la retorica di una fedeltà individuale ad elementi astratti e collettivi quali “nazione”, “stato”, “Costituzione”, “democrazia”, ecc.), a un pacifismo utopistico che tollera il soldato come male necessario e in cui si favorisce l’obiezione di coscienza e la “pompierizzazione” delle FFAA, viste soprattutto come agenti di protezione civile e assistenza in caso di calamità pubbliche. In diversa misura queste componenti ideologiche hanno contribuito a qualificare (o dequalificare, a seconda dei punti di vista) la condizione militare sino agli anni Settanta.In diversa misura queste componenti ideologiche hanno contribuito a qualificare (o dequalificare, a seconda dei punti di vista) la condizione militare sino agli anni Settanta.
Terzo: con la fine delle ideologie e il “riflusso” reaganiano negli anni Ottanta, e soprattutto con la fine della Guerra Fredda, si afferma un “pensiero tecnico” (come lo chiamano i filosofi contemporanei) che impone al militare un modello economico-manageriale e tecnologico. Tutti noi ricordiamo la propaganda di reclutamento per gli Ufficiali in SPE che insisteva oltre misura, ispirandosi a un modello nordamericano applicato in Vietnam, sulla figura di Comandante quale abile manager di un’azienda che produce “difesa” in modo efficiente e misurabile in termini di costi/benefici (ovviamente materiali).
Quanto poi sia realistica, in Italia, la realizzazione di un apparato pubblico governato da meri criteri di efficienza, come una qualsiasi impresa privata, lascio giudicare al comune cittadino…
Quarto: nel trapasso avvenuto negli anni Novanta da una FA stanziale a coscrizione obbligatoria ad una tendenzialmente di proiezione e professionalizzata, s’inserisce il motivo epocale della crisi dei “pensieri forti”, che non sono soltanto le ideologie ispiratrici delle diverse aggregazioni politiche, ma anche la stessa “ideologia della scienza”, cioè lo scientismo, inteso come fiducia assoluta nelle capacità della scienza di “spiegare il mondo” e risolverne i problemi.
A ben guardare, le crisi locali (ex-Iugoslavia, vicino Oriente, Caucaso ecc.) che hanno necessitato o necessiterebbero l’uso della forza multinazionale sono solo l’espressione geopolitica di una condizione più generale – direi antropologica – che riguarda tutta la civiltà contemporanea: la frammentazione delle certezze e dei valori di riferimento, incluso quello di una scienza “neutrale” e rassicurante.
In questo quadro, che molto rozzamente ho sintetizzato nei quattro punti appena descritti, va collocata la condizione militare e la questione della sua specificità: “vocazione” o “professione”, nell’era del “pensiero debole”?
A mio avviso il problema motivazionale è governato dal rapporto fra alcuni fattori fondamentali e dalla gerarchia in cui siano disposti. Devo tuttavia rilevare, al riguardo, che la riduzione di tali fattori motivazionali al campo economico, psicologico e politico rischia di non fornire una risposta convincente alla questione della specificità della condizione militare.
Infatti le motivazioni di ordine economico non fanno la differenza con le altre professioni pubbliche o private: denaro, privilegi di rango, prestigio sociale sono molle potenti per qualsiasi genere di ambizione ‘laica’; allo stesso modo, le motivazioni di ordine psicologico (autostima, orgoglio di status, desiderio di novità o di avventura, idealismo sociale e umanitario, ecc.) sono fungibili presso qualsiasi forma di impiego: dall’impresa pubblica, a quella privata, alle ONG. Lo stesso dicasi per le motivazioni politiche, relative al potere contrattuale acquisibile nell’ambito dei rapporti pubblici e privati.
Cosa dunque farebbe della condizione militare una “vocazione” dotata di valore aggiunto, peculiare rispetto alle altre forme di professione?
Per rispondere a questa domanda in modo convincente dobbiamo, a mio avviso, cercare in contesti culturali precedenti a quello moderno: nella classicità, nelle radici stesse della condizione militare. In una parola, nella memoria. Non c’è identità senza memoria, e – aggiungo – nessuna memoria diventa azione (e trasformazione) se non ha un riferimento concreto.
La nostra classicità sono il mondo greco-romano, barbarico medievale e cristiano; ma essa è solo storia libresca, vuota retorica, senza un collegamento fattuale e concreto. Dov’è che la “poesia” delle guerre di Omero, dell’Eneide o della Gerusalemme liberata diventa carne e sangue?
Dove possiamo concretamente conoscerla?
La risposta, per chi ha militato nei ranghi delle Aviotruppe, è immediata, ed è stata esposta con chiarezza nei due passi che ho citato in epigrafe, tratti dal celebre libro sui Ragazzi della Folgore e dal più recente lavoro di Emilio Camozzi: si tratta di El Alamein e della sua memoria vivente!
Ciò che i due autori definiscono “poesia” mostra una direzione di ricerca assai stimolante sotto il profilo filosofico: un mix etico ed estetico che precisa la scelta militare come vocazione specifica, supererogatoria rispetto alle motivazioni (pur legittime) di tipo economico, psicologico o politico.
Essa non le annulla, ma certamente le supera, poiché supplisce in tutti i momenti e i luoghi in cui esse sono carenti o addirittura assenti. Sono i fatti stessi a dimostrarlo. Cosa inchiodava, infatti, il Fante dell’Aria alla sua buca; cosa lo spingeva all’assalto con mezzi inadeguati; cosa lo obbligava a rinunciare di sua volontà alla sostituzione o al ricovero? Non la paga, non il prestigio, non le convinzioni politiche o altro.
Direi invece un senso di fedeltà al suo dovere più prossimo: al “suo” compagno di buca, alla “sua” squadra o plotone, al “suo” comandante. Questo è confermato dalla stragrande maggioranza dei racconti che ho raccolto dalla viva voce dei reduci.
È stato scritto che “non c’è amore più grande di quello di colui che sacrifica la propria vita per quella dei suoi fratelli”, e questo è ciò che ha prodotto il «Fattore E. A.» (El Alamein): un valore aggiunto capace di surrogare la tecnica e la competenza, la vera molla dell’eroismo, un eroismo tutto particolare che trova le sue forme nella fratellanza d’arme, trasformando strumenti ed esperienze potenzialmente negativi e di morte, quali la guerra e gli artifici offensivi, in strumenti positivi di vita. Una vita, naturalmente, che merita la “v” maiuscola.
Credo che in tempi di disorientamento morale e di frammentazione del pensiero come quelli che stiamo innegabilmente vivendo, la motivazione della memoria simbolizzata dal «Fattore E. A.» possa costituire un esempio fruibile per le generazioni e, in particolare, per tutti coloro che si sentono attratti dall’antico mestiere delle armi senza magari neppure saperne spiegare dettagliatamente il perché (come i “ragazzi” immortalati da Bechi Luserna).
Per essi, e per noi che ci occupiamo di queste cose, il «Fattore E. A.» è un elemento concreto d’identità e di distinzione. Dovremmo esibirlo nelle nostre “campagne” (anche quelle umili e quotidiane) come i legionari spagnoli del Tercio fanno con l’occhio di Millan Astray o quelli francesi della Lègion con la mano di legno di Danjou.