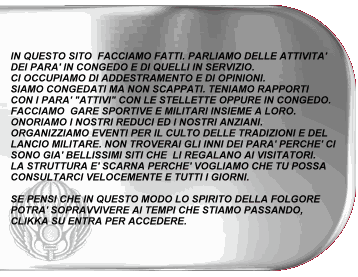Pubblicato il 10/03/2021
RASSEGNA STAMPA: REPUBBLICA PARLA DEL NONO REGGIMENTO COL MOSCHIN- VIDEO E ARTICOLO

foto: archivio
Livorno, Gianluca Di Feo: “Nella base degli incursori, dove i parà si preparano per le missioni top secret
La realtà del Nono reggimento “Col Moschin”, le forze speciali italiane. Nella caserma di Livorno si vive un clima da start up, per mettere a punto gli equipaggiamenti e addestrarsi in vista delle operazioni più difficili. Spedizioni che restano sempre segrete, dall’Afghanistan alla Somalia, dall’Iraq al Sud Sudan. Gli incursori sono circa duecento, scelti dopo una selezione che dura due anni tra lanci d’alta quota e immersioni subacquee. Tutti hanno una specializzazione: tiratori scelti, esperti di esplosivi, soccorritori di prima linea, coordinatori di attacchi aerei. E sono pronti a entrare in azione con un preavviso di pochi minuti. Ma la loro quotidianità è lontana dagli stereotipi alla Rambo
riprese Sonny Anzellotti
montaggio Lorenzo Urbani
immagini Esercito italiano
L’ARTICOLO
LIVORNO a caserma ha l’architettura sciatta della leva, che rievoca tempi andati di guardie al bidone e marce nel cortile. Dentro però l’atmosfera è da start up, dove la concretezza prende il sopravvento sulla formalità militare: si discute di problemi da risolvere e obiettivi da raggiungere, senza badare troppo alla gerarchia. Prima che ufficiali e soldati, qui tutti sono incursori: una qualifica che comporta capacità straordinarie e un senso del dovere tale da rendere superflui gli ordini. Siamo nel comando livornese del Nono Reggimento “Col Moschin”, l’élite combattente dell’Esercito. In quella che a livello internazionale viene chiamata “la comunità delle forze speciali”, questo reparto occupa un posto d’onore: eredi degli arditi della Grande Guerra, sono considerati l’archetipo di tutti i commandos del mondo e hanno dimostrato sul campo di essere all’altezza della leggenda.
Negli ultimi vent’anni il termine “forze speciali” è stato spesso abusato, fino a mutarlo nell’icona di supermen amplificata da dozzine di film, serie tv e giochi da Playstation. Entrare nella realtà del “Col Moschin” cambia radicalmente la prospettiva: non c’è retorica e anche la marzialità è rara. Tutto è dominato dall’imperativo dell’operatività. Ogni giorno affrontano una gamma incredibile di questioni, perché gli uomini oltre ad avere le capacità fisiche di un incursore, devono essere paracadutisti d’altissima quota, sommozzatori, specialisti nel tiro di precisione o nella demolizione o nel soccorso medico in prima linea o nel coordinare gli attacchi aerei. E devono potere intervenire in qualunque continente con un preavviso di pochi minuti. Questo vuol dire mantenere sempre pronti armi e strumenti, dai fuoristrada ai gommoni d’assalto, tutti personalizzati. Qui nulla è standard, ogni dotazione è “su misura” per operare in deserti o ghiacciai: paracadute, abiti, scarpe, veicoli, mitra. Le aziende li usano come sparring partner per mettere a punto gli equipaggiamenti più avanzati e adesso stanno collaborando alla progettazione del nuovo fucile automatico Beretta per l’Esercito. La creatività non manca. Un esempio? Nella caserma c’è una torre alta cinquanta metri che si usava per asciugare all’interno i vecchi paracadute: l’hanno trasformata in una palestra di arrampicata, con appigli pure su superfici inclinate, per allenarsi nelle pause giornaliere.
Le pareti di corridoi e uffici sono lastricate con foto e cimeli di oltre un secolo di attività, che negli ultimi tre decenni li ha portati ovunque. Dalla Somalia a Timor Est, dalla Repubblica Centroafricana al Sud Sudan, dalla Bosnia al Mozambico. «Io sono andato dove gli altri non volevano andare — recita la “poesia del soldato”, appresa dai colleghi americani — . Io ho portato a termine quello che gli altri non volevano fare».
Ci sono anche le grandi bandiere nere dell’Isis catturate a Mosul. «Sono il dono del reparto iracheno che abbiamo addestrato, una testimonianza di stima per il nostro sostegno», precisa il colonnello Yuri Grossi che guida il Nono, indicando il vessillo delle truppe scelte di Baghdad che hanno espugnato la roccaforte del Califfato. Di commandos alleati ne hanno formati tanti: nel 2015 nel Kurdistan minacciato dallo Stato Islamico si sono ritrovati tra le reclute alcuni dei bambini che venticinque anni prima avevano nutrito e protetto dai pretoriani di Saddam Hussein. Per gli incursori insegnare non è un’attività neutrale: significa restare “spalla a spalla” con gli allievi pure nelle operazioni a ridosso della linea del fuoco, esponendosi agli stessi pericoli. Nell’autunno 2019 proprio in una di queste missioni due di loro sono rimasti gravemente feriti nelle montagne curde dove Daesh si sta riorganizzando. Ma i veterani ricordano soprattutto la felicità dei commilitoni iracheni ogni volta che un villaggio veniva liberato dal terrore jihadista.
Inutile chiedere dettagli sulle azioni, la riservatezza è totale. Non parlano dei raid della Task Force 45, che in Afghanistan dava la caccia ai capi dei talebani. Solo le storie dei caduti vengono rese note, come quella del capitano Alessandro Romani morto nel 2010 per salvare un convoglio da un’imboscata. Un drone aveva avvistato dei miliziani che piazzavano una trappola esplosiva sul percorso degli alpini e gli incursori sono intervenuti con un elicottero. Appena atterrati, sono finiti sotto un fuoco infernale. Romani è stato colpito due volte, ma è rimasto a sparare, coprendo i suoi uomini. «Gravemente ferito, negli ultimi istanti di vita anteponeva il dovere alla propria incolumità, preoccupandosi del buon esito della missione», è la motivazione della medaglia alla memoria, identica nei toni a quelle degli arditi che nel 1917 con pugnali e granate espugnarono le trincee del Col Moschin.
Ancora più segrete le spedizioni condotte per conto della presidenza del Consiglio, che da cinque anni può disporre direttamente delle forze speciali. Libia? Siria? Yemen? La replica è un sorriso muto. Si preparano anche alle minacce in patria: si esercitano a liberare ostaggi, simulando blitz nelle case, sui bus, sugli aerei e persino sui traghetti. Vederli andare all’arrembaggio è sorprendente. Nel pieno della notte si paracadutano sul mare con quattro gommoni smontati, poi in otto minuti esatti li assemblano in mezzo alle onde e avviano i motori. Arrivano silenziosi sotto le fiancate della nave e le scalano con i rampini, sincronizzando l’irruzione nel buio.
In caserma le divise sono l’eccezione. Indossano un miscuglio di tute mimetiche e tenute sportive, scegliendo quello che reputano utile, e non mostrano i gradi: tanto si conoscono tutti, perfettamente, e sono tutti incursori, dal generale al soldato semplice. Per ottenere la qualifica e il basco grigioverde hanno dovuto superare ventiquattro mesi di corso spietato: uno su cento ci riesce, finora nessuna donna ce l’ha fatta. Poi altri due anni per specializzarsi: ad esempio il cecchino o l’esperto di esplosivi, come quelli che hanno partecipato alla demolizione del Ponte Morandi. Si dice siano poco meno di duecento, con età media che supera i trent’anni. E non è un mestiere per teste calde: dal vero, sono lontani dallo stereotipo di Rambo che una certa retorica di destra gli ha appiccicato addosso. Sanno che il controllo dei nervi deve essere sempre assoluto, perché ognuno mette la vita nelle mani del compagno. «Non si può essere incoscienti, anzi bisogna sempre fare i conti con la paura: serve per rendersi conto dei rischi e agire nel modo migliore», spiega il colonnello Grossi. Impossibile nascondere un cedimento: la sorveglianza è reciproca e continua; condividono servizio e vita privata, come una grande famiglia. La tana è la base che si trova proprio sulla foce dell’Arno, isolata nel parco di San Rossore: l’hanno costruita praticamente da soli. Ha un’atmosfera da film di 007, circondata da torrette, con gli hangar dei gommoni e i magazzini di dotazioni speciali. È il luogo da dove nelle emergenze partono di corsa in elicottero verso gli aeroporti. E dove ogni anno incursori ed ex portano mogli e figli per commemorare i caduti.
Gli ultimi entrati nella “famiglia” sono i cani da battaglia. Altre nazioni li usano da anni, il Col Moschin ha preferito aspettare per scegliere le razze e le tattiche migliori. Oggi sono nove, vivono con i loro “conduttori” e fanno tutto insieme a loro, incluso lanciarsi con il paracadute: il cane legato al torace dell’incursore, le lunghe orecchie al vento e ogni tanto una carezza sul muso. Dicono che in azione siano imbattibili, soprattutto quando bisogna irrompere nelle abitazioni: scattano per primi e neutralizzano i nemici con una rapidità che nessun umano può eguagliare. Nei blitz anche gli animali indossano occhiali protettivi e giubbotti antiproiettile: sono elementi preziosi della squadra. Inevitabile chiedergli: perché lo fate? La risposta è corale: «Di certo non per la paga, che prevede un’indennità minima rispetto agli altri reparti. È una scelta di vita, fatta di impegno e sacrifici ma che può dare grandi soddisfazioni: essere un incursore è un’esperienza unica». Esistenze decisamente particolari. Uno di loro è appena tornato dall’Antartide, dove ha accompagnato una spedizione scientifica. Un gruppo discute l’esercitazione per l’indomani: c’è stata una nevicata, si può sfruttare per paracadutarsi in montagna. Di armi parlano poco: ne hanno d’ogni tipo, pure quelle dei nemici, e le trattano come ferri del mestiere, senza enfasi. Niente bicipiti da body building, ma «l’atleticità della fatica»: corsa, arrampicata, nuoto, bicicletta, ogni giorno ore e ore di allenamento. Il fiato che in un villaggio del Kurdistan o in una gola dell’Afghanistan farà la differenza tra la vita e la morte. Quando? Forse proprio in questo momento una squadra sta prendendo posizione insieme agli allievi iracheni che assalteranno un fortino dell’Isis. Loro però non lo racconteranno mai.