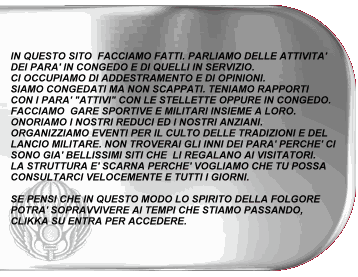Pubblicato il 24/06/2014
PIRATERIA: A BORDO DELLA FREGATA IL BERSAGLIERE
I PIRATI DEL TERZO MILLENNIO
di Sergio Ramazzotti
Yacht
Da un lato la difesa: la nave si chiama Bersagliere, è una fregata della Marina militare italiana, 188 gli uomini di equipaggio, 113 i metri di lunghezza, impressionante la potenza di fuoco, con un cannone 127/54 da 25 tonnellate in grado di polverizzare un bersaglio a oltre cento chilometri, due cannoni 40/70, due sistemi di difesa antiaerea e antinave con un totale di 24 missili, due mitragliere pesanti Browning, due mitragliere 20/70 e quattro mitragliatrici calibro 7,62 MG, due delle quali montate su un elicottero, il tutto controllato da una centrale da guerra elettronica di ultima generazione.
Dall’altro lato la minaccia: un dhow, il barcone da trasporto in legno diffuso in tutto l’oceano Indiano, costruito a mano come mille anni fa da un maestro d’ascia somalo, sospinto da un motore diesel arrugginito smontato da un camion, a bordo un paio di skiff o lance veloci, rampini d’arrembaggio legati a corde di canapa, qualche vetusto fucile mitragliatore AK-47, nel migliore dei casi un lanciagranate RPG di fabbricazione sovietica, viveri e acqua potabile ridotti all’osso e l’equipaggio composto da una mezza dozzina di uomini cui resta ben poco da perdere: i pirati del terzo millennio. Una minaccia che, negli ultimi tempi, è tornata a farsi sentire appieno con l’audace sequestro, lo scorso febbraio, della petroliera italiana Savina Caylyn nell’Indiano e, pochi giorni dopo, con l’uccisione dei quattro occupanti statunitensi della barca a vela Quest, intercettata dai pirati a 375 miglia dall’Oman, e il rapimento (il 24 febbraio) nel sud del Mar Arabico di una famiglia danese che stava terminando il suo giro del mondo in barca a vela con i loro tre figli (tra i 12 e i 16 anni) e con una coppia di amici.
La contrapposizione minaccia-difesa è l’essenza dell’operazione Ocean Shield, lanciata dalla Nato nell’agosto del 2009 per contrastare, con l’impiego della Task Force 508, cinque navi da guerra (fra cui, da ottobre 2010, il Bersagliere) e il sommergibile olandese Zeeleeuw in pattugliamento nelle acque del Corno d’Africa, il fenomeno sempre più virulento della pirateria che origina dalle coste somale, e che negli ultimi anni ha causato, oltre alle numerose vittime, danni devastanti (intorno ai 16 miliardi di dollari, secondo un rapporto commissionato dal Congresso statunitense) alla navigazione mercantile e al commercio globale, mentre, secondo il ministero degli Esteri del Kenya, soltanto nel 2008 avrebbe fruttato ai bucanieri oltre 150 milioni di dollari in riscatti sborsati dagli armatori delle navi sequestrate. Di fronte a queste cifre, è chiara la necessità di una missione come Ocean Shield, imponente (costa circa 350 milioni di dollari l’anno) ma imprescindibile.Dalla plancia di comando del Bersagliere, con 2500 tonnellate di acciaio che fendono l’oceano sotto di noi e i nove metri di cannone puntato verso l’orizzonte, le acque del Golfo di Aden non sembrano granché ostili. La nave percorre senza sosta il proprio settore, rotta SW, poi NE, ancora SW, 12 nodi costanti fra la costa somala e quella yemenita, la routine quotidiana immutabile: ogni mattina alle cinque il reparto volo prepara l’elicottero, un AB212 modificato con pannellature antiproiettile in kevlar, per il pattugliamento. Decollo all’alba, intorno alle sei, a bordo i due piloti e un radarista che, in caso di necessità, diventa mitragliere e dispone di due MG calibro 7,62 montate su entrambi i lati.
L’alba e il tramonto sono i momenti preferiti dai pirati per attaccare i mercantili: c’è luce sufficiente per distinguere una nave da carico e non rischiare di abbordarne una da guerra (è successo con la rifornitrice della Marina francese Somme, indovinate come è finita per i pirati), ma non abbastanza perché gli skiff, sottili come aghi e capaci di spunti a 30 nodi, possano essere avvistati in lontananza da una vedetta. Mentre l’elicottero è in volo, sveglia per l’equipaggio. Alle otto la quick reaction force, una squadra di 10 incursori del reggimento San Marco, è in stand by, pronta a calarsi in mare su una motobarca e un gommone in una manciata di minuti per salire a bordo di un dhow sospetto, mentre nella sala controllo macchine, sulla plancia di comando, nella centrale di controllo dove si trovano le postazioni radar e di guerra elettronica, nelle cucine, nell’hangar retrattile dell’elicottero, nell’infermeria e in quella specie di fucina di Vulcano che alloggia due motori diesel da 8000 cavalli e due turbine aeronautiche da 50.000, 180 uomini fanno funzionare la nave con la precisione di un orologio. E come all’interno del meccanismo di un orologio, la vita di bordo finisce per essere ripetitiva, per alcuni monotona.
La nave, almeno in fatto di ergonomia, è di concezione superata, gli spazi sono ridotti, le cuccette nel ponte inferiore anguste come bare, nei corridoi, in ogni angolo libero, sono state piazzate macchine da palestra, cyclette e set da sollevamento pesi per poter scaricare la tensione, nel pomeriggio il ponte di volo diventa pista (sempre troppo corta) da jogging. Gli incursori del San Marco, molti veterani dell’Afghanistan e dell’Iraq, fremono, dicono: «Laggiù era meglio, almeno succedeva sempre qualcosa».
Qui, quel che può succedere è di incrociare uno dei rari dhow che arrancano a 100, talvolta 200 miglia dalla costa, innocui all’apparenza, e spesso anche nella sostanza, ma dato che più del volume di fuoco è la disperazione a rendere il nemico letale, e un pirata somalo è per definizione disperato (sono i morsi della fame a spingerlo ad arrembare un mercantile in un’azione ai limiti del suicidio), le regole d’ingaggio impongono di trattare ogni dhow come se avesse a bordo uomini armati della specie più pericolosa: quelli, appunto, che non hanno niente da perdere. Di solito un dhow pirata si riconosce a distanza da segnali inequivocabili: ha almeno un paio di skiff sul ponte, sei o sette persone a bordo, nessuna bandiera e un telone di plastica steso sulla coperta. Quest’ultimo è il particolare più agghiacciante: non per la sua funzione principale (nascondere le armi e proteggerle dalla salsedine), ma per quella secondaria.
«I pirati sono talmente alla fame», mi ha detto il comandante del Bersagliere, il capitano di fregata Gennaro Falcone, «che non di rado si spingono anche a 500/600 miglia dalla costa stivando solo il carburante per il viaggio d’andata. Se l’attacco riesce, si impossessano di una nave e tutto va bene. Se fallisce, o se non individuano un obiettivo prima di finire il carburante, il telone diventa una vela, e loro rimangono in balia del vento e del mare a mille chilometri da terra, con parecchie possibilità di lasciarci la pelle. Per ironia, a quel punto se gettano le armi in mare, e accade, per il codice di navigazione internazionale sono naufraghi a tutti gli effetti, e hanno diritto a essere soccorsi da noi che dovremmo arrestarli, o dal mercantile che avrebbero potuto assaltare».
L’approccio ai dhow segue sempre lo stesso schema: la fregata accosta a distanza di sicurezza (un disperato messo alle corde e armato di RPG potrebbe sempre decidere di morire portando con sé quanti più nemici possibile), un tiratore scelto sale sulla controplancia e tiene sotto controllo la barca attraverso il cannocchiale di un fucile di precisione, nel frattempo gli uomini del San Marco, armati fino ai denti, si avvicinano con i gommoni per ispezionarla. A bordo, oltre all’armamento per rispondere a un eventuale attacco, portano bottiglie d’acqua e sigarette: se il dhow, come accade spesso, è un semplice peschereccio, sono doni per l’equipaggio, sempre apprezzatissimi, quasi sempre ricambiati con uno squalo o un pescespada appena pescati. Il dhow viene comunque fotografato e, come si usa dire in sala controllo, “taggato” (la guerra elettronica usa il linguaggio di Facebook, o forse è il contrario), quindi inserito nel sistema informatico che le navi della Task Force 508 utilizzano per scambiarsi informazioni in tempo reale, in modo da evitare che venga fermato una seconda volta.
Il vero incubo (burocratico) arriva se durante l’ispezione a bordo i militari scovano il kit da arrembaggio di cui si diceva sopra: a quel punto il comandante deve mettersi alla fonda, assicurare il dhow, disporre l’arresto dell’equipaggio (a questo proposito il Bersagliere dispone di gabbie in corda: rudimentali, ma occupano uno spazio minimo e servono bene allo scopo) e organizzare un processo in videoconferenza, con un avvocato difensore e un magistrato che sulla base delle prove deciderà se convalidare o meno il fermo. In caso di condanna, i pirati vanno tenuti a bordo fino al rientro della nave in patria, dove sconteranno la pena, o tradotti (con un contorsionismo legale che non sempre riesce) a scelta nelle galere di Gibuti, delle Seychelles o del Kenya, i paesi dell’area firmatari di un accordo con l’Unione Europea, ma non con la Nato, in virtù del quale possono punire il reato di pirateria per conto terzi. «Tuttavia», dice il comandante Falcone, «il nostro è più che altro un compito di interdizione e di polizia: la nostra presenza nel Golfo di Aden serve a rassicurare i mercantili che lo attraversano, e dissuadere i pirati dall’assaltarli.
Al tempo stesso, però, dobbiamo stare attenti a non diventare un fastidio per il traffico locale, i pescherecci e i dhow da carico, ed è per questo che dopo ogni controllo regaliamo qualcosa. È un modo per scusarci del tempo che abbiamo fatto perdere”. Un tempo, aggiungeremmo, che in nessun’altra operazione militare come in questa è stato, letteralmente, denaro.
Leggi anche