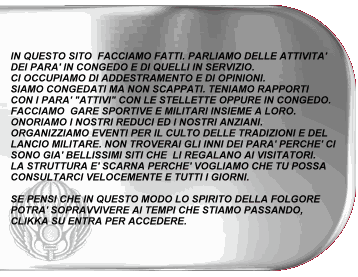Pubblicato il 19/03/2015
RASSEGNA STAMPA- LIBERTA’ DEL 19 MARZO 2015

Piccolo racconto di un lontano 25 aprile
Era arrivata in una notte di luna piena, paracadutata su un pianoro dell´Appennino
di LUIGI ZAZZALI
Piccolo racconto di un 25 aprile.
Era arrivata in una notte di luna piena, infiltrandosi oltre le linee tedesche, paracadutata su un pianoro dell’Appennino insieme a una radio campale, una cassa di mitra e due di munizioni (l’oculata parsimonia sulle pallottole faceva comprendere subito che si trattava di una missione britannica).
Si chiamava Alexandra. Si chiamava Alexandra e non ce n’erano state altre, prima, come lei. Non c’erano state altre come lei, prima; e dopo non ci sarebbe più stata una come lei. Ufficialmente era un’ausiliaria della RAF, l’aviazione di Sua Maestà. In realtà era un’agente sotto copertura del SOE – Special Operations Executive – la speciale struttura voluta da Winston Churchill per infiammare i paesi conquistati dalla Germania mediante sabotaggi, appoggio ai movimenti di resistenza, spionaggio e quant’altro potesse tornare utile ai bisogni di una guerra. Era stata reclutata perché figlia di due fuoriusciti italiani, originari della provincia di Pisa, che avevano a suo tempo deciso di non rimanere a vivere in una nazione in cui tutti dovevano mettersi in nero.
L’arrivo presso il distaccamento Fiamme verdi “Dino Ferroni” non fu particolarmente movimentato. La combinazione di lancio e il nerofumo in viso non permisero di intuire subito che si trattasse di una donna. Fu la voce a renderlo evidente; una voce dove una lieve accentuazione della erre sostituì più che degnamente il profumo, piuttosto fuori luogo sul campo di guerra. La sorpresa degli uomini dell’unità fu smorzata rapidamente dall’ordine di caricare il materiale paracadutato sui basti di due muli; i quali attendevano placidi, poco lontano, piuttosto ignari degli accadimenti bellici.
La prima notte trascorse nella silenziosa tranquillità della montagna. Il mattino seguente la nuova arrivata cominciò a prendere familiarità con il territorio su cui avrebbe operato come agente di collegamento. Iniziarono così giorni di marce non interrotte, necessarie tanto per conoscere la zona d’operazioni quanto per rimediare all’errore fatto da Londra, dove evidentemente si ignorava che la guerra della fanteria si declina come il verbo “marciare”.
L’agente del SOE, infatti, aveva bisogno di parecchio allenamento.
Fu in una breve pausa di riposo, durante una marcia, che Alexandra rivolse una domanda al comandante del distaccamento. «Chi era questo Dino Ferroni? Un antifascista? ». «Anche», rispose il partigiano, già caporalmaggiore degli alpini. «Era il mio tenente in Russia. Alla fine di gennaio dell’anno passato, durante il ripiegamento dal Don, arrivammo a un villaggio nei pressi di una linea ferroviaria, tenuto in forze dai russi. I primi reparti giunti a contatto col nemico cercarono subito di sfondare. Il nostro plotone prese la stazione ferroviaria del paese e la tenne… »
Un istante di silenzio fece di ghiaccio la primavera che li circondava.
«… la tenne finché non furono tutti morti. Solo allora i russi riuscirono a riprenderla». E poi aggiunse, rapido, a scansare la domanda che già incombeva: «Quel giorno io ero indietro, con la slitta dei feriti, per via del congelamento alla gamba che ancora mi fa zoppicare. Per questo sono vivo».
Con l’estate iniziarono le operazioni sul terreno. Giorni e notti trascorsi in appostamenti e raccolta di informazioni, nel silenzio degli uomini e delle armi; perché ogni contatto col nemico poteva significare il fallimento della missione, o peggio la distruzione del reparto. Un’attività oscura, misconosciuta, che aveva contribuito ad affibbiare al distaccamento partigiano qualche nomignolo ironico da parte di altre bande della zona; ignare del fatto che ogni pur rara comunicazione radio effettuata da Alexandra scatenava i cacciabombardieri alleati sulle unità tedesche.
Venne l’autunno; e con le foglie morte il giorno più duro del “Dino Ferroni”. Un forte reparto della Wehrmacht muoveva verso il fronte. Dopo averlo sorvegliato per giorni, era arrivato il momento di far conoscere ai comandi alleati le informazioni recuperate. Quello di cui, però, i partigiani non si erano accorti, era il radiolocalizzatore che seguiva le truppe
tedesche.
Le bombe di mortaio iniziarono a cadere quando la trasmissione radio si era appena conclusa. Il tiro era allargato, per far tenere giù la testa agli uomini dell’unità intanto che le squadre d’assalto tedesche serravano le distanze. La Breda 38 del distaccamento aveva già iniziato a sparare. Raffiche brevi e precise, presto però interrotte da un proiettile di mortaio esploso vicino; il capo-arma e uno dei serventi morti, l’altro servente con una gamba aperta da una scheggia.
«Comandante… » si rivolse il ferito al caporalmaggiore, arrivato sbalzando fino alla postazione della mitragliatrice. «Brutta ferita, vero? ». Non ci fu risposta; non serviva.
«Maledizione. Voi toglietevi di qua. Io… mio fratello mi aspetta».
Nei film e nei libri ci sarebbero, a questo punto, scene inverosimili e lunghissime. Nella realtà ci fu solo un tirato «Addio, Franco», mormorato al ferito dal comandante mentre già si allontanava, tirandosi dietro Alexandra e gli altri partigiani dell’unità. L’ancestrale patto fra uomini in armi non ha bisogno di molte parole; soprattutto quando intorno cadono colpi di mortaio. Le secche raffiche della Breda 38, che aveva ripreso a sparare per coprire il ripiegamento dei superstiti, testimoniarono come ancora una volta il patto fosse stato onorato.
Fu solo nel cuore della notte, dopo una giornata corsa su sentieri ignoti ai più, sfinendosi pur di sfuggire ai tedeschi, che gli uomini del distaccamento si concessero una sosta per riposare. Mentre consumavano razioni ben misere, Alexandra si avvicinò al gruppo e fece una domanda. «Cosa significava quella frase… mio fratello mi aspetta? ».
Nessuno rispose. Come per una superiore consapevolezza, tutti avevano capito che una sola persona poteva affrontare una simile domanda. Il comandante del distaccamento comprese; e parlò, pesando parole che bruciavano più del fuoco.
«Franco era soltanto il nome di battaglia. Il ragazzo alla mitragliatrice si chiamava in realtà Giuseppe. Giuseppe Ferroni. Era il fratello minore del mio tenente. Io ero in montagna solo per lui, perché di guerra non ne posso più… La madre, quando Giuseppe aveva deciso di sottrarsi al bando di arruolamento della Repubblica Sociale, mi era venuta a cercare a casa, per chiedermi – anzi: per implorare – di seguirlo. Perché almeno lui tornasse vivo».
Soltanto più tardi, quando ormai la notte si era fatta vecchia, nell’accampamento improvvisato si udirono altre parole. Erano quelle di un canto sommesso, antica canzone di soldati e di proscritti e di tutti quanti hanno una sola speranza: poter rivedere ancora una volta il sole.
«… fra le rocce noi viviam, ci disprezza ognuno perché laceri noi siam… »
Alexandra si avvicinò piano al caporalmaggiore, che poco discosto fumava un mozzicone di sigaro, lusso inaudito dei giorni di battaglia.
«Quanti anni hai? », gli chiese.
«Eh!? », rispose l’uomo, preso del tutto alla sprovvista.
«Ti ho chiesto quanti anni hai» ripeté lei.
In sottofondo, continuava il canto dolente degli uomini in cerchio.
«… sparsi in branchi come lupi ad aspettar… »
Pensò qualche secondo, prima di rispondere. «Non si chiede l’età, alle donne e ai soldati. Non è elegante. Però… però i vecchi alpini e le belle ragazze hanno vent’anni per sempre. Siamo coetanei, insomma».
Un battuta idiota, forse. Ma lei sorrise; sorrise per la prima e ultima volta durante la sua permanenza presso il distaccamento Fiamme verdi “Dino Ferroni”. Lei sorrise, e il caporalmaggiore capì di essere perso.
Sono passati gli anni. C’è una piccola abitazione, sul fianco di una collina, e un vecchio seduto in poltrona. Accanto il fuoco, e sul trave del camino una foto ingiallita, che mostra due giovani in uniforme; cugini, forse, vista la somiglianza. Vicino a questa una consunta busta chiusa; ormai è illeggibile il nome della persona a cui era indirizzata.
La sera del 24 aprile del 1945, quella stessa lettera veniva affidata a un giovane partigiano dal comandante la sua unità – che stava uscendo per l’ultima missione della guerra – affinché l’indomani la consegnasse a un’agente di collegamento britannico. Quando gli uomini rientrarono all’accampamento, nel pomeriggio del giorno dopo, la lettera era ancora lì. Prima di essere recuperato da un plotone delle Coldstream Guards, l’operatrice del SOE a cui era destinata aveva rifiutato di leggerla. Evidentemente necessita meno coraggio l’essere paracadutati in territorio nemico, che offrire una possibilità al destino e agli uomini.
Ci sono ore in cui la vita dei singoli sembra battere in accordo con la storia. La speranza spezzata da quella lettera rifiutata gli sembrò, da subito, presagio della sorte che attendeva ben altre speranze, che in quei giorni si infiammavano e che il tempo avrebbe provveduto a spegnere; più lentamente, forse, ma altrettanto inesorabilmente. Se però un giorno la speranza era divampata… allora, chissà, domani avrebbe potuto bruciare nuovamente. Dopo tutto, forse aveva ragione il monito letto anni prima su un monumento ai Caduti: “mai disperare nei destini d’Italia”.
L’uomo guardò ancora una volta i due soldati nella foto, e poi si addormentò.