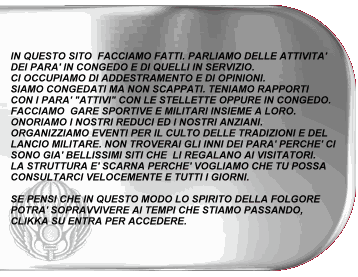Pubblicato il 28/03/2015
RASSEGNA STAMPA
| ESPRESSO 13 sezione: SOMMARIO data: 2/4/2015 – pag: 9 |
Esclusivo Esclusivo EsclusivoLe guerre segrete d’Italiadi |
| Prima l’Afghanistan, ora Iraq e Somalia. Dove contrastano già l’avanzata jihadista. Ecco chi sono e come operano i nostri soldati d’élite impegnati nelle missioni più riservate |
| Massimo Sestini |
| I nomi delle missionI irichiamano l’epica antica, tornata di moda anche tra i soldati più giovani sull’onda del “Gladiatore” con Russell Crowe. Operazione “Sarissa” in Afghanistan, come la lunga lancia della falange di Alessandro il Grande. “Prima Parthica” in Kurdistan, come la legione di Settimio Severo che sconfisse l’impero persiano. O più banalmente “Centurion” dalle parti di Baghdad, con meno fantasia dovuta all’influsso dell’alleato americano. Oppure si usano acronimi dal suono esoterico come “Bnms Gibuti” o “Eutnm Somalia”. È dietro queste sigle che si mimetizzano i reparti italiani impegnati a contrastare l’avanzata dei jihadisti, che si chiamino talebani, Is, Al Qaeda o al-Shabaab. Mentre la strage di Tunisi fa sentire la minaccia alle porte di casa e spinge a schierare un’altra flotta a largo della Libia, ci sono militari che stanno già fronteggiando il fondamentalismo armato. Rapidi e invisibili, come nelle canzonette della propaganda littoria, ma estremamente efficaci. E richiestissimi dai comandi occidentali, che li vorrebbero far intervenire ovunque. L’Afghanistan è stato il laboratorio del nuovo modo di agire degli italiani: combattere senza esplicitarlo, muovendosi sul confine delle autorizzazioni parlamentari. Non servono tanti soldati, basta che siano capaci e soprattutto discreti: poche decine di commandos che agiscono nell’ombra servono più dei battaglioni e dei bombardieri. Sono le “Special Forces”, protagoniste della guerra moderna. Per gli americani hanno la stessa importanza delle armi atomiche: possono decidere le sorti di un conflitto, ma spesso basta solo la loro presenza per intimidire i nemici e spingerli a tenersi lontani. Il modello tricolore è la Task Force 45, così famosa da diventare presto una fiction Mediaset, così misteriosa da non sapere cosa abbia fatto in otto anni di battaglie. Eppure sono meno di duecento uomini, in gran parte operatori del Col Moschin (in codice “Condor 34”) a cui si aggregano distaccamenti di incursori della Marina ( “Caimano 69”), di arditi dell’Aeronautica (“Icaro 30”) e di carabinieri del Gis. Insomma, l’élite guerriera italiana. Di sicuro, è la prima forza operativa sottratta al diretto comando nazionale: per otto anni ha obbedito al quartier generale della Nato di Kabul e quindi soprattutto agli americani. Ed è anche la prima a non restare in difesa: va sempre all’attacco, in cerca di “prede di valore”, i leader talebani e i tecnici che confezionano trappole esplosive. CACCIA GROSSA I risultati sono top secret. Ufficialmente il nostro Paese non ha mai catturato prigionieri, né ha mai ucciso nemici. Una versione smentita dai file di WikiLeaks, rivelati da “l’Espresso” tre anni fa, che elencavano decine di vittime. E ora le foto di una monografia pubblicata da un editore specializzato, la Lupo di Luca Poggiali, mostrano gli incursori senza volto mentre ammanettano afghani, medicano talebani feriti negli scontri o gli “fotografano” gli occhi per prendere il profilo dell’iride. Un’altra attività che non riguarda la nostra sicurezza nazionale: gli scanner sono statunitensi e le informazioni finiscono in un database in Florida. Tanto che solo pochi mesi fa il governo si è posto il problema della legittimità di queste schedature (vedi box a pag. 21), senza trovare una soluzione. Un’altra immagine dello stesso libro è l’unica che lascia intuire le spedizioni di caccia grossa, quelle che la Nato definisce con un elegante eufemismo “assalti cinetici”. Si vede un’auto semicarbonizzata sulla Ring Road, la grande strada afghana, circondata dalle jeep dei commandos e da un elicottero da combattimento Mangusta. Verosimilmente, sulla vettura viaggiavano dei capi talebani. Un drone li ha seguiti dall’alto, poi è scattato l’agguato. Con un paio di colpi da lunga distanza un cecchino ha bloccato il motore, quindi sono arrivati i parà sotto la protezione del Mangusta: le portiere aperte indicano che le persone a bordo sono state catturate ancora vive. Un raid da manuale. Altre volte invece è finita male. Nel settembre 2010, durante il blitz per neutralizzare i guerriglieri che avevano piazzato bombe letali contro gli alpini, è morto il tenente Alessandro Romani: i nemici erano appostati in zona, forse grazie al doppiogioco di un informatore. ADDESTRAMENTO “ATTIVO” Con la ritirata dall’Afghanistan da gennaio anche la Task Force 45 è stata dimezzata e ha ridotto le azioni: la base di Farah, nella regione più calda, è stata smantellata. Rimane soltanto uno squadrone a Herat, dove si è arroccato il contingente italiano, che salirà sull’ultimo elicottero entro fine anno. Ma per le teste di cuoio non è prevista tregua: c’è già un altro fronte che li richiama, la prima linea contro il sedicente Stato Islamico. Il nostro impegno in Iraq non prevede il combattimento. Al Parlamento è stata annunciata solo una missione di addestramento. Giusto, ma la disciplina atlantica offre un’interpretazione ambigua, perché divide questa attività in due compiti ben diversi: training e mentoring. Il training è quello che si fa nelle caserme, lontano dalla linea del fuoco: si insegnano tecniche e tattiche, si spara alle sagome nei poligoni. Il mentoring invece si spinge molto oltre: si vive assieme ai soldati da istruire, seguendoli in battaglia. Anche in questo caso, l’Afghanistan è stata la palestra decisiva. Contro i talebani, i fanti afghani sono andati all’attacco “shona ba shona”, spalla a spalla, con i mentor italiani. Non è un caso se i mezzi più potenti spediti laggiù, i cingolati Dardo, siano serviti proprio per questo impiego: scortavano le avanzate degli allievi locali. E in Afghanistan i Dardo, con i loro cannoni da 25 millimetri, hanno consumato il maggior numero di proiettili in assoluto. Nei discorsi sulla lotta allo Stato Islamico, il ministro Roberta Pinotti non ha mai pronunciato il termine “mentoring”; lo ha fatto però il suo collega degli Esteri Paolo Gentiloni durante la visita a Baghdad. Significa che una parte delle special forces italiane non resterà nei campi trincerati della zona verde della capitale: potrà entrare in azione assieme ai colleghi iracheni. E lo stesso avverrà sulle linee dei peshmerga – letteralmente “coloro che intendono battersi fino alla morte” – del Kurdistan. C’è poi un appello pressante degli americani per mettere a disposizione un team specializzato nell’indicare i bersagli dei bombardamenti, un compito estremamente pericoloso. Al momento è ancora presto, solo un centinaio dei 320 uomini destinati all’Iraq sono già sul campo. Adesso è più urgente insegnare ai curdi l’uso delle armi donate dal nostro Paese, formando sniper per il tiro di precisione e artificieri per stanare le trappole esplosive. E bisogna completare le infrastrutture per accogliere i nostri elicotteri. Come al solito, gli operatori delle forze speciali saranno pochi: il numero non conta, è la qualità a fare la differenza. RITORNO A MOGADISCIO “Mentoring” è anche la parola chiave per decifrare il ruolo italiano in un altro quadrante caldo del jihad: la Somalia. Pochi giorni fa è stata annunciata la fine della spedizione contro la pirateria, ma rimarrà attiva la base di Gibuti, l’unico fortino stabile fuori dai confini: una sentinella sul Corno d’Africa. Formalmente quella somala è una missione europea, di fatto la gestiamo noi. Il comando e oltre la metà degli uomini – più di cento – sono nostri. Stiamo tirando su dal nulla l’esercito nazionale: abbiamo addestrato finora oltre quattromila reclute, a cui doneremo anche una cinquantina di vecchie camionette blindate – gli “Scarrafoni”, apprezzati per la loro robustezza – e ci occupiamo della sicurezza delle installazioni internazionali. Siamo diventati pure i consiglieri dello Stato maggiore di Mogadiscio, lo stesso incarico a cui si dedicava un cittadino italo-somalo partito da Firenze, l’architetto Abdisalam Hagi, assassinato lo scorso agosto durante un attacco fondamentalista. La capitale resta ad alto rischio: un mese fa un’autobomba ha devastato un hotel accanto alla residenza del premier. E la guerriglia islamica di al-Shabaab viene considerata una minaccia primaria da Washington, perché dispone di legami con la diaspora somala in tutto l’Occidente. Per contenerla gli americani si sono affidati alle esecuzioni dei droni-killer – quattro capi jihadisti uccisi solo negli ultimi mesi – ben felici di delegare ad altri le iniziative sul terreno. UN ESERCITO DI VETERANI A riportare il tricolore a Mogadiscio è stato il generale Massimo Mingiardi, ex numero uno della Folgore che proprio lì venne ferito nel 1993 durante la battaglia al Check Point Pasta: «C’è ancora tanto da fare. La missione deve essere potenziata, servono soldi e militari. Ho chiesto altri soldati, sto ancora aspettando. Sono un ufficiale operativo, abituato a stare insieme ai miei uomini e conosco le loro necessità. Posso dire di avere sempre gli stivali sporchi di sabbia, perché mi piace stare sul campo», ha detto Mingiardi poco prima di venire rimpiazzato – pare con un discreto anticipo rispetto ai tempi stabiliti – dall’alpino Antonio Maggi. È un altro generale con esperienza combat maturata nella valle afghana di Mushai, che – come scrisse il “Washington Post”nel 2007 – nessuno prima di lui era riuscito a pacificare. Il fatto che siano tutti veterani non deve sorprendere. Dal 2003 abbiamo mandato decine di migliaia di uomini al fronte, dove si sono abituati ad agire secondo le tattiche più avanzate. E stiamo investendo per rendere l’armata di forze speciali sempre più numerosa: nel 2012 il comandante dell’Esercito Claudio Graziano ha dichiarato a “l’Espresso” che si puntava ad avere 2500-3000 commandos italiani. Da allora si lavora per raggiungere questo obiettivo, potenziando i ranghi: altri incursori del Col Moschin, altri ranger del Monte Cervino e del Rao. Pedine preziose per le missioni discrete del futuro prossimo. L’Aeronautica dal canto suo ha capito da tempo quale sarà l’arma decisiva: i droni. Siamo stati il primo Paese europeo a schierare i Predator, accumulando esperienza in Afghanistan e in Libia. Per mesi, ne abbiamo fatti decollare due da Gibuti, non solo per tenere d’occhio i pirati ma anche per studiare dall’alto le mosse degli al-Shabaab. Adesso altri Predator sono in Kuwait assieme ai Tornado da ricognizione e tutti i giorni sorvolano le postazioni dell’Is a nord di Baghdad. Dopo un lungo veto, gli americani ora sono disposti a fornirci pure gli apparati per dotare di missili gli aerei-robot: un acquisto inserito nella lista della spesa dell’ultimo bilancio della Difesa. Tra un anno arriveranno altri droni ancora più potenti, completamente Made in Italy: i Piaggio che somigliano agli “squali martello”, un nomignolo che anticipa la vocazione di bombardieri teleguidati a lungo raggio. E sempre facendo tesoro della lezione statunitense, ci si prepara a modificare alcuni bimotori da trasporto in cannoniere volanti, con armi a tiro rapido progettate per spazzare via i caposaldi avversari. IL DILEMMA LIBICO Uomini e tecnologie pronti a ogni evenienza, anche a un intervento in Libia. Una spedizione evocata sempre più spesso per soffocare i germogli dello Stato Islamico che sembra trovare consensi crescenti nell’opinione pubblica, perché le stragi di Parigi e di Tunisi hanno alzato la percezione del pericolo, mai come oggi sentito vicino. Ma nessuno deve farsi illusioni: sbarcare in Tripolitania o in Cirenaica sarebbe facile, imporre una pace quasi impossibile. Non potrebbero esserci vie di mezzo, né operazioni nell’ombra perché chiunque metterà piede a Derna o Misurata rischierà di ritrovarsi in una guerra vera. I generali sanno cosa vuol dire: tra scontri e incidenti, in Afghanistan hanno dovuto contare 53 caduti e 650 feriti. E si trattava di un conflitto “a bassa intensità”, contro miliziani male armati e senza sostegno internazionale, mentre in Libia circola ogni genere di ordigno e si intrecciano gli interessi di tutte le potenze, arabe e non. Insomma, intervenire sull’altra sponda del Mediterrano significa infilarsi in un nido di vespe. Siamo pronti a pagarne il prezzo? Prima l’Afghanistan, ora Iraq e Somalia. Dove contrastano già l’avanzata jihadista. Ecco chi sono e come operano i nostri soldati d’élite impegnati nelle missioni più riservate |