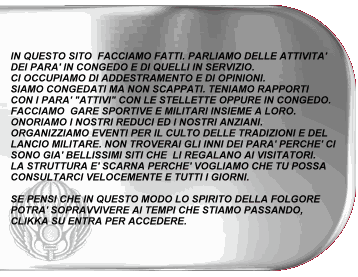Pubblicato il 07/03/2017
IL TENENTE COLONNELLO PAOLO FILIPPINI CI RACCONTA LA SUA STORIA DI MILITARE E DI CAMPIONE- IL SALUTO DEL GEN. BERTOLINI

Il Ten. Col. Paolo Filippini, che ha recentemente concluso col collocamento in quiescenza la sua lunga carriera di atleta militare di maggior successo del Centro Sportivo Esercito ora ribattezzato Reparto Attività Sportive, ripercorre qui la sua vita, con uno scritto brillante ed efficace. Molti si riconosceranno nei suoi ricordi.
Gen. Marco Bertolini
Ringrazio Congedati Folgore per aver seguito il mio saluto alla vita militare del 31 gennaio scorso e per aver commentato il fatto con parole così lusinghiere.
La successiva proposta di scrivere qualche pagina sulla mia vita personale, militare e sportiva mi ha ulteriormente gratificato ma anche un po’ preoccupato. Infatti ritengo che comunicare con voi, cioè con chi si sente legato alla Brigata paracadutisti Folgore, sia un grande onore ma anche una grande responsabilità.
La prima domanda che mi sono posto è: “Quanto e cosa scrivere?”
Ho sempre vissuto intensamente inseguendo i miei tanti (forse troppi) sogni e progetti.
Di cose da raccontare ne avrei tante, ma questa per me è un’occasione speciale e abbastanza formale. Quindi avrei deciso di essere conciso, dando un po’ più di spazio solo agli episodi della mia vita che ritengo più significativi e pertinenti. A malincuore ho rinunciato a citare le persone che, a vario titolo, sono state importanti per me. Sono troppe, non avrei potuto nominarle tutte. Sento però il bisogno di ringraziare almeno le Istituzioni e i miei cari. Ma basta con i preamboli, confidando nella vostra benevolenza, vado a cominciare.
Credo di essere stato il classico ragazzo di campagna. Sono nato il 26 marzo 1961 a Castelnuovo Berardenga in provincia di Siena, vicino a quel colle della battaglia di Monteaperti citato da Dante nella Divina Commedia.
Ho passato la mia infanzia (forse non s olo quella) convinto di essere Tarzan, con un fisico sicuramente non adeguato al personaggio.
olo quella) convinto di essere Tarzan, con un fisico sicuramente non adeguato al personaggio.
Comunque, a forza di arrampicarmi sugli alberi, diventai una specie di scimmietta polivalente e molto intraprendente. Quando avevo circa dieci anni oltre a cercare di imitare Tarzan mi cimentai con l’equitazione. Il mio destriero aveva caratteristiche molto particolari e grossi limiti in…altezza: cercavo di usarlo come un cavallo ma era un maiale che avevo addomesticato. Tutto finì un giorno quando ripresi i sensi in riva al fiume, dove mia sorella mi aveva trasportato per bagnarmi la fronte, dopo una caduta al galoppo dalla schiena priva di appigli del mio compatto destriero. Cominciai a fare sport alle scuole medie, un po’ di podismo e calcio nella squadra del paesino.
Il Mister, nell’inutile tentativo di scoprire il mio talento, mi fece provare tutti i ruoli; dal portiere al centravanti, per poi rassegnarsi a farmi giocare in difesa. Peccato, perché anche oggi riesco facilmente a fare decine di palleggi consecutivi, il problema è che sul campo non sono mai riuscito a capire dove dovevo buttare il pallone. Dai quattordici ai diciassette anni tralasciai un po’ lo sport, forse perché ero distratto dalle differenze che notavo fra il mio fisico e quello delle ragazze. Ma nel 1978 scoprii casualmente la prima grande passione sportiva della mia vita: il karate. Sono passati quasi quarant’anni, sono cintura nera 5° Dan dal 1997 e mi diverto ancora. In quinta liceo scientifico pensavo di aver deciso che da grande volevo fare il professore di educazione fisica. Poiché dovevo adempiere gli obblighi del servizio militare, tanto valeva togliersi subito il pensiero, per poi iscriversi all’ISEF di Firenze. Fu così che all’inizio del 1981, il non ancora ventenne Paolo Filippini varcò il portone della Scuola Militare di Paracadutismo di Pisa.
La scelta di fare il servizio di leva nei paracadutisti, oltre che avvincente, era funzionale al progetto di diventare insegnante di educazione fisica. Infatti, sapevo che durante il corso per paracadutista militare avrei potuto partecipare alle selezioni per provare a diventare AIP, cioè Aiuto Istruttore di Paracadutismo. Pensavo che sarebbe stata un’ottima esperienza per l’ISEF. Andò tutto come previsto, superai le selezioni, mi brevettai e cominciai subito il nuovo corso. Probabilmente quelle sono state le cinque settimane più intense della mia vita. Avete presente il film “Ufficiale e gentiluomo”? A parte le trascurabili differenze estetiche fra me e l’attore protagonista e il fatto che il mio istruttore non fosse di colore, per il resto le cose non andarono molto diversamente.
Vi racconto un piccolo aneddoto. Una mattina dell’aprile 1981, dopo un’ora di corsa e un’altra ora di esercizi a corpo libero, uno di noi cinque allievi AIP stava cercando di esporre una lezione teorica. Man mano che il malcapitato proseguiva nella sua sofferta performance didattica, gli occhi del nostro istruttore diventavano due fessure sempre più sottili fino a quando esplose così: “Voi cinque imbranati, avete dieci minuti di tempo per indossare di nuovo l’uniforme ginnica e presentarvi davanti alla porta della palestra”.
A dire il vero le parole non furono proprio queste, ma certe cose è meglio non scriverle. Comunque il senso era proprio quello, infatti nove minuti e trenta secondi dopo, arrivando di corsa, lo trovammo sulla porta della grande palestra, cuore e tempio della caserma, con il cronometro al collo e lo sguardo sinistro. I tre quarti d’ora seguenti furono penosi: venti giri di cinquecento metri l’uno, passando ogni volta davanti a quella porta dove l’istruttore controllava “i tempi sul giro”; cioè altri dieci chilometri di corsa dopo i tredici percorsi quella stessa mattina oltre ad un’ora di ginnastica. Di quelle cinque settimane ci sarebbero da raccontare tante altre cose, come i salti sul telo da undici metri d’altezza o le salite alla fune di nove metri con lo zainetto sulle spalle. Ormai avevo vent’anni ma a pensarci bene, forse ero ancora convinto di essere Tarzan come quando ne avevo meno della metà; solo che invece di arrampicarmi sugli alberi della campagna senese, salivo sull’impalcatura per i salti sul telo e sulle funi della grande palestra della SMIPAR di Pisa.
Cosi cominciai a fare l’Aiuto Istruttore di Paracadutismo, con il proposito di iscrivermi all’ISEF di Firenze nell’autunno dello stesso anno. Ma quello che facevo mi piaceva troppo, e decisi di presentare domanda per rimanere in servizio almeno un altro anno e poi un altro ancora, senza rinunciare all’idea di terminare gli studi. Di quegli anni ho dei ricordi bellissimi. Ancora oggi, dopo oltre trent’anni, in giro per l’Italia mi capita di essere fermato da qualcuno dei miei allievi di allora e quasi sempre vedo occhi che si accendono, nel ricordo e nella nostalgia di emozioni indimenticabili. Nel 1983 rinunciai a un corso sperimentale di lanci in caduta libera, realizzato appositamente per selezionare aspiranti atleti per la Sezione Paracadutismo del Centro Sportivo Esercito (CSE). Quella decisione la presi perché ero ancora convinto di voler fare l’insegnante di educazione fisica (avevo già superato qualche esame) e perché facevo parte della squadra toscana di karate, illuso di poter conseguire grandi risultati agonistici.
All’inizio del 1984 mi resi conto che il mio status di Sergente Istruttore di Paracadutismo, anche se mi piaceva molto, non mi permetteva di prepararmi alle competizioni della mia amata arte marziale in modo adeguato. La vita militare mi piaceva, lo sport mi entusiasmava, partecipai con ottimi risultati ad alcune competizioni militari e quando mi fu chiesto nuovamente di entrare a far parte della squadra del CSE, accettai. Il karate e l’ISEF diventarono i miei hobby e nel settembre del 1984 cominciai a fare di professione quello che ho fatto fino al 31 gennaio 2017. Per la maggior parte dei trentasei anni della mia vita militare ho avuto la grande fortuna di alzarmi la mattina e sentirmi felice, nel senso espresso in una frase, letta o sentita non ricordo dove ma rimasta impressa nella mia mente in modo indelebile: “La felicità non è fare ciò che si vuole ma volere ciò che si fa”. Il 19 settembre 1985, con grande emozione, vidi nascere il mio primo figlio Fabio. Al CSE, che oggi si chiama RAS cioè Reparto Attività Sportive, cominciai rapidamente a ottenere buoni risultati. Nel 1988 avevo già vinto tre campionati italiani assoluti individuali e facevo ormai parte della nazionale italiana.
Nel 1990, ad Altenstadt in Germania, vinsi il mio primo campionato del mondo militare a squadre e mi piazzai quarto nella classifica individuale. Il 18 marzo 1991, qualche giorno prima di compiere trent’anni, discussi la mia tesi sul paracadutismo sportivo, chiudendo la lunga parentesi dell’ISEF con un bel 110 e lode. Nell’ottobre del 1992 pubblicai quella tesi e come fanno gli scrittori veri, ci misi una dedica che suona così: “Dedico questo libro a tutte quelle persone che, a causa di handicaps, incidenti o malattie, non possono gioire del libero uso di un corpo sano”. Se oggi, dopo un quarto di secolo, potessi riscrivere quella dedica, penso che la rifarei identica. Il corpo e la mente sono doni preziosi, mi piace provare a esplorarne tutte le potenzialità; allenare il mio fisico in modo sano, rispettandolo, è per me quasi un dovere oltre che un grande piacere. Vedere il sorriso di un allievo, che si accorge di aver fatto anche solo un piccolo miglioramento, mi emoziona. Vorrei che tutti e in particolare chi ha delle limitazioni motorie, potessero “gioire del libero uso di un corpo sano”. Ma prima di andare avanti, torniamo al 1991, perché circa un mese dopo aver discusso la mia tesi all’ISEF mi accadde qualcosa di veramente particolare. Stavo guidando a Firenze, dove ero arrivato qualche ora prima con un amico per sostenere un esame pratico di karate.
Accadde tutto improvvisamente e non durò più di due minuti. Fu come se fossi stato catapultato in una dimensione surreale, per poi ritrovarmi di nuovo nella vita normale, disorientato e svuotato di ogni energia. Tornando verso Pisa, all’altezza del Parco delle Cascine, mentre stavo per imboccare il Ponte della Vittoria, vidi una persona seduta sulla spalletta verso valle, al centro del ponte e rivolta verso il vuoto. Un attimo dopo, quando ero ancora a una distanza di circa venti metri, si buttò di sotto. Salii con la macchina sul marciapiede, corsi verso il punto in cui era sparita e mi affacciai. Vidi la giacca di pelle scura e la nuca di questa persona galleggiare immobili. La corrente era molto veloce a causa delle forti piogge dei giorni precedenti. Sembrava svenuta, la faccia completamente immersa, l’Arno la stava portando via. Avevo addosso scarpe, jeans e camicia. Non mi tolsi niente perché in quell’attimo pensai (sbagliando) che non ci fosse tempo da perdere. Scavalcai la spalletta e mi buttai immediatamente. Lasciai sul ponte il mio amico esterrefatto e rischiai di pagare molto cara la mia passione di tuffatore autodidatta. Infatti agli inizi degli anni 80 avevo fatto tanti tuffi dalle scogliere della costa e delle isolette della Calabria tirrenica, arrivando gradualmente a quasi venti metri di altezza. Naturalmente mi piaceva tuffarmi di testa, come da bambino avevo visto fare al mio idolo Tarzan, quando si tuffava per salvare Jane dalle fauci del coccodrillo (menomale che nell’Arno i coccodrilli non ci sono).
Quando staccai i piedi dal Ponte della Vittoria, con l’acqua che scorreva rapida una decina di metri sotto di me, lo feci d’istinto, così com’ero abituato a fare e cioè a testa in giù. Ma in volo, nell’attimo in cui dubitai che la profondità dell’acqua fosse sufficiente, sentii il morso della paura. In una frazione di secondo capii che non sarei riuscito a girarmi in tempo per affrontare la superficie del fiume con i piedi, così come sarebbe stato saggio fare, e dovetti entrare in acqua di testa. Potei solo cercare di non andare troppo in profondità, cercando comunque di non spezzarmi la schiena e tenendo le braccia protese verso il fondo. La piena del fiume fu provvidenziale, le mie mani urtarono senza danni contro una roccia del fondo. Riemersi più in fretta che potei, cercando di individuare l’aspirante suicida. La vidi subito a circa trenta metri di distanza, ancora immobile e con la faccia tutta sott’acqua; naturalmente cercai di raggiungerla nel minor tempo possibile. Quando arrivai a un paio di metri la vidi girarsi lentamente sul dorso e capii che non era svenuta. Non so se lo fece perché mi sentì arrivare o perché non ce la faceva più a trattenere il respiro, ma vidi che era una donna e temetti che mi si aggrappasse addosso, facendo affogare anche me. Per questo mi fermai a poco più di un metro; la corrente ci stava portando via ma pensai che non ci fossero pericoli immediati, visto che ormai galleggiava con bocca e naso fuori dall’acqua e mi sembrava che respirasse. Ero alle sue spalle, allungai lentamente una mano e la afferrai per il colletto della giacca dietro alla nuca, pronto a difendermi se avesse cercato di usarmi come salvagente. Ma lei rimase completamente immobile e io cominciai a trascinarla verso la riva destra. L’acqua era fredda, quando arrivai vicino alla sponda ero stremato. Lei sembrava in trance, chiesi aiuto a un pescatore che ci osservava sbigottito e insieme riuscimmo a trascinarla in cima all’argine. Mi girai verso il ponte che era a circa trecento metri di distanza. Quello che vidi, per quanto eccezionale, servì a riportarmi alla realtà. La spalletta era gremita di gente, il traffico completamente bloccato, perché gli autisti che avevano visto la scena avevano fermato le vetture sul posto ed erano corsi a vedere cosa succedeva.
Sulla stradina appena fuori dalla sponda sulla quale mi trovavo, si avvicinava una macchina della Polizia Municipale. Fui scosso da un brivido ed ebbi la sensazione di svenire; probabilmente avevo consumato tutta l’adrenalina che mi si era riversata in circolo due minuti prima. Arrivò di corsa il mio amico che mi coprì con il mio accappatoio, lo stesso che avevo usato meno di un’ora prima, dopo la doccia al termine dell’esame di karate. Mentre i vigili urbani mi chiedevano cosa era successo, arrivò un‘ambulanza che portò via la donna. Chiesi di essere portato anch’io in ospedale perché, anche se pensavo di non aver bevuto, l’acqua dell’Arno a Firenze non è certo potabile e volevo chiedere a un medico se potevo stare tranquillo. In ospedale, dove arrivai tremante e avvolto nel mio accappatoio, inizialmente fui scambiato per un pazzo, poi fui tranquillizzato. Avrei voluto fare una doccia calda ma mi dissero che non era possibile (questa cosa non l’ho mai capita). Allora chiesi qualcosa di asciutto e mi offrirono un lenzuolo, ne chiesi due e mi accontentarono. Mi sciacquai come potei in piedi davanti ad un lavandino, usai un lenzuolo per asciugarmi e mi avvolsi nell’altro, tipo Giulio Cesare. Rilasciai una dichiarazione alla Polizia Municipale, misi i miei indumenti bagnati dentro una grande busta nera per la spazzatura e, sempre avvolto nel mio lenzuolo asciutto, mi avviai fuori dall’ospedale dove mi aspettava il mio amico con la mia macchina. Nel corridoio incontrai di nuovo il medico che mi aveva visitato poco prima. Mi parlò della donna che avevo salvato, dicendomi che aveva già cercato di togliersi la vita e mi chiese se volevo salutarla. Lei era immobile seduta su una barella, con lo sguardo perso nel vuoto; gli chiesi come stava. Con un filo di voce e senza girarsi verso di me disse: “Era meglio se mi lasciavi morire”.
Sono uscito da quell’ospedale con il vuoto nel cuore e di lei non ho saputo più niente.
Nel 1993 vinsi il concorso per transitare nella  categoria Ufficiali. Gli anni novanta sono stati il mio periodo d’oro dal punto di vista agonistico. In quel decennio sono arrivati quasi tutti i miei nove titoli di Campione del Mondo (sette di squadra e due individuali). Nel settembre 1996, quando mancavano meno di tre mesi alla nascita della mia secondogenita Gaia, riuscii a conquistare il mio primo titolo di Campione del Mondo individuale, stabilendo anche due record mondiali. Il nome della cittadina dell’Ungheria dove si svolse quel campionato è quasi impronunciabile: “Bekescsaba”. Mi sentivo in forma ma avevo uno stato d’animo molto particolare. Avevo già vinto tre Campionati del mondo a squadre, arrivando anche quarto nella classifica individuale. Ora volevo salire anche da solo sul gradino più alto del podio più difficile. Però non mi illudevo, ormai sapevo quanto è difficile vincere un mondiale individuale. Ero pronto ad accettare serenamente qualunque cosa fosse successa ma ero ancora più pronto a dare il massimo. Arrivammo sul posto tre giorni prima dell’inizio della competizione, in modo da poter fare qualche lancio di allenamento. Ero proprio in forma, facevo dei lanci quasi perfetti, sembrava che fosse il bersaglio a venire con me. Mi sentivo pronto per il grande risultato. Ero geloso di questa potenzialità che sentivo dentro di me, vivevo sereno ma cauto, attento a tutto ciò che avrebbe potuto infrangere il mio stato di grazia. Fin dall’inizio fu una gara snervante, caratterizzata da una scarsa organizzazione e da lunghe pause dovute alle cattive condizioni meteorologiche ma la Squadra Italiana sembrava proprio imbattibile. Eravamo Campioni del Mondo in carica e fin dal primo lancio fu evidente che potevamo riconfermarci. Le giornate passavano lente e ancor più lentamente si succedevano i lanci, rallentati dalla mediocre gestione degli aerei e da lunghe piogge. Libri, musica, partite a pallavolo, chiacchiere con gli amici di tutto il mondo servivano a ingannare le attese. L’Italia manteneva la testa della classifica provvisoria a squadre ed io continuavo a non sbagliare. Nel primo lancio in più di venti avevamo ottenuto il massimo risultato e cioè zero centimetri di errore. Ma lancio dopo lancio qualcuno commetteva un piccolo errore, spesso un solo centimetro, e il numero dei paracadutisti che avevano fatto sempre zero diminuiva…
categoria Ufficiali. Gli anni novanta sono stati il mio periodo d’oro dal punto di vista agonistico. In quel decennio sono arrivati quasi tutti i miei nove titoli di Campione del Mondo (sette di squadra e due individuali). Nel settembre 1996, quando mancavano meno di tre mesi alla nascita della mia secondogenita Gaia, riuscii a conquistare il mio primo titolo di Campione del Mondo individuale, stabilendo anche due record mondiali. Il nome della cittadina dell’Ungheria dove si svolse quel campionato è quasi impronunciabile: “Bekescsaba”. Mi sentivo in forma ma avevo uno stato d’animo molto particolare. Avevo già vinto tre Campionati del mondo a squadre, arrivando anche quarto nella classifica individuale. Ora volevo salire anche da solo sul gradino più alto del podio più difficile. Però non mi illudevo, ormai sapevo quanto è difficile vincere un mondiale individuale. Ero pronto ad accettare serenamente qualunque cosa fosse successa ma ero ancora più pronto a dare il massimo. Arrivammo sul posto tre giorni prima dell’inizio della competizione, in modo da poter fare qualche lancio di allenamento. Ero proprio in forma, facevo dei lanci quasi perfetti, sembrava che fosse il bersaglio a venire con me. Mi sentivo pronto per il grande risultato. Ero geloso di questa potenzialità che sentivo dentro di me, vivevo sereno ma cauto, attento a tutto ciò che avrebbe potuto infrangere il mio stato di grazia. Fin dall’inizio fu una gara snervante, caratterizzata da una scarsa organizzazione e da lunghe pause dovute alle cattive condizioni meteorologiche ma la Squadra Italiana sembrava proprio imbattibile. Eravamo Campioni del Mondo in carica e fin dal primo lancio fu evidente che potevamo riconfermarci. Le giornate passavano lente e ancor più lentamente si succedevano i lanci, rallentati dalla mediocre gestione degli aerei e da lunghe piogge. Libri, musica, partite a pallavolo, chiacchiere con gli amici di tutto il mondo servivano a ingannare le attese. L’Italia manteneva la testa della classifica provvisoria a squadre ed io continuavo a non sbagliare. Nel primo lancio in più di venti avevamo ottenuto il massimo risultato e cioè zero centimetri di errore. Ma lancio dopo lancio qualcuno commetteva un piccolo errore, spesso un solo centimetro, e il numero dei paracadutisti che avevano fatto sempre zero diminuiva…
Al termine della penultima giornata di gara erano state effettuate solo cinque manches, cioè solo cinque lanci a testa ma affinché il campionato venisse convalidato, era necessario completare almeno la sesta manche.
Quella sera, cioè la sera del penultimo giorno, fu per me estremamente delicata. Infatti, eravamo solo in due ad aver fatto cinque centri e quindi mi trovavo exequo in testa alla classifica individuale. Naturalmente lo sapevano quasi tutti e quando, poco prima di cena, si presentò una giornalista per intervistarmi non mi sorpresi più di tanto. Quella notte riuscii a dormire abbastanza bene, anche se io ho sempre avuto il sonno delicato; era come se stessi recitando un copione che avevo studiato per tanti anni. Arrivò la mattina dell’ultimo giorno che fra l’altro prevedeva il termine della competizione nel primo pomeriggio, cioè appena sei ore di tempo (dalle 0800 alle 1400) e… stava piovigginando.
Se le condizioni meteorologiche fossero peggiorate non sarebbe stato possibile convalidare la gara e tutti i nostri sforzi sarebbero stati vani. Neanche i cinque centri consecutivi che avevo inanellato sarebbero serviti a niente. Verso le nove, sotto una leggera pioggerella, cominciò la gara. Come prevede il regolamento, le squadre che si trovavano ultime nella classifica provvisoria furono le prime a lanciarsi; l’Italia che era in testa, sarebbe stata l’ultima. A quel campionato del mondo partecipavano più di trenta Nazioni, con il ritmo che stavano tenendo si poteva prevedere che il nostro turno sarebbe arrivato verso le 1200. Infatti, poco prima di mezzogiorno arrivò la fatidica “fifteen minutes call”, cioè chiamata dei quindici minuti. Ma credo che il modo migliore di raccontarvi l’epilogo di quella gara, sia quello di riportarvi la fine dell’articolo che scrissi appena rientrato in Italia per una rivista specializzata del tempo: “… la mattina del 22 settembre il cielo non prometteva niente di buono, c’erano appena 900 metri di quota e scendeva una leggera pioggerella. Con queste premesse iniziavano i lanci, nel tentativo di completare il sesto round e poter quindi assegnare tutti i titoli. Man mano che si avvicinava il nostro momento, aumentava la consapevolezza che sarebbero bastate poche ore di pioggia un po’ più forte per vederci scivolare di mano, o meglio dal collo, varie medaglie che ormai sembravano così vicine. Arrivava la chiamata dei 15 minuti, poi quella dell’imbarco. Mentre il nostro Antonov AN 2 (vecchio biplano russo con le ali in tela) circuitava sulla cittadina di Gyula in attesa di lanciarci, le condizioni meteorologiche peggioravano ulteriormente. Guardando dall’oblò non sapevo se augurarmi che ci facessero scendere o che ci lasciassero “saltare”. L’ordine di tornare a terra non arrivò e ci lanciammo nella pioggia. Fuori dal misterioso biplano che sfiorava il grigio tetto di nubi, la situazione mi sembrava irreale; forse per la tensione o forse per l’acqua che gocciolava copiosa dal paracadute ormai zuppo. Ma il terreno si avvicinava e non mi sembrava il caso di sognare ad occhi aperti. Un attimo dopo aver colpito il bersaglio, i due zeri apparsi sulla centralina mi dicevano che probabilmente ero io il nuovo campione del mondo. Ma intanto eravamo stati scavalcati dalla squadra della Repubblica Ceca e, come se non bastasse, un componente della squadra polacca doveva ripetere il lancio perché il sistema di misurazione non aveva funzionato. Quindi il sesto round non era ancora valido e la delusione per quello che era successo alla nostra Squadra era grande: dopo il quinto lancio avevamo un buon vantaggio sui secondi, e se noi italiani non fossimo stati gli unici a fare l’ultimo lancio con una pioggia così forte, ben difficilmente avremo perso la testa della classifica. Dopo il rejump del polacco la gente cominciava a farmi i complimenti ma la mia gioia si era come congelata. Sentivo un nodo alla gola, avevo voglia di piangere ma non ci riuscivo. Poi la premiazione, il piacere e l’orgoglio di rappresentare l’Italia, da solo sul gradino più alto di un podio mondiale.
Fino al 2000 i campionati del mondo assoluti di paracadutismo si disputavano ogni due anni (negli anni pari) ma anche il 1997, pur senza mondiale, fu molto ricco di successi internazionali. Arrivò il 1998, io avevo “idee agonistiche” molto bellicose anche se non stavo attraversando un periodo molto sereno. Il viaggio per il campionato del mondo fu in macchina, destinazione Vrsar, ridente paesino sul bel mare della Croazia. Si dormiva in un villaggio turistico, a pochi metri dagli scogli che invitavano a tuffarsi nell’acqua pulita e subito profonda. Anche questa volta ero in grande forma ma gli ultimi giorni prima dell’inizio della gara cominciai a sentirmi molto nervoso. Il primo giorno di gara fu tremendo, nelle ultime due notti avevo riposato malissimo e purtroppo sapevo per esperienza che in quelle condizioni potevo sbagliare molto più facilmente. Il primo lancio fu abbastanza brutto per la Squadra Italiana ma io riuscii a fare centro. Aspettando il secondo lancio che sarebbe arrivato in tarda mattinata, decisi di prendere un altro caffè, dopo quello della colazione, perché avevo paura di un calo di lucidità.
Quel lancio, anche se meno del terzo, fu molto difficile dal punto di vista tecnico a causa del vento in aumento e della particolare orografia della zona. Il bersaglio era collocato a meno di cento metri dal porticciolo, in un avvallamento delimitato a nord dalla vecchia Vrsar e a sud da una collinetta boscosa costellata da moderni alberghi. Se il vento era debole o proveniva dal mare, cioè da ovest, lo spostamento della massa d’aria sopra al bersaglio era abbastanza regolare. Ma quel giorno soffiava da sud e nel corso della mattinata aumentò d’intensità, fin quasi a raggiungere il limite massimo consentito di sette metri al secondo. La massa d’aria in movimento, dopo aver superato la collina, ricadeva nella zona del bersaglio diventando molto turbolenta e controllare la traiettoria del paracadute era molto difficile. Quando fu il nostro turno di effettuare il secondo lancio, avevamo già visto alcune squadre, anche molto brave, fare grossi errori. L’ultima fase di avvicinamento al bersaglio fu estremamente adrenalinica ma, in barba alla turbolenza, riuscii a portare il mio corpo nella posizione ideale per colpire il bersaglio. Nell’ultima frazione di secondo, appena prima di poggiare il piede sul congegno elettronico, successe. Una leggera contrazione involontaria del muscolo anteriore della coscia e il tacco della mia scarpa, invece di colpire il centro del bersaglio, finì appena più avanti. Incredulo osservai il display che quantificava il mio errore: DUE CENTIMETRI. Troppi, anche UNO sarebbe stato troppo. In quel periodo avevo seri motivi personali per essere nervoso ma ero andato a fare quella gara per vincerla, non per passare notti insonni e poi fare un errore del genere, che quasi sicuramente mi aveva messo fuori gioco. Quella maledetta contrazione muscolare involontaria l’avevo sentita bene, improvvisa, inaspettata, irrimediabile… o quasi. Andai a ripiegare il paracadute trasudando rabbia impotente ma neanche gli altri quattro della Squadra Azzurra stavano molto meglio di me. Anche qualcuno di loro nei primi due lanci aveva fatto errori notevoli e ora l’Italia si trovava circa al decimo posto della classifica provvisoria a squadre. Pensavo a quel secondo caffè preso un paio d’ore prima, per darmi la carica perché mi sentivo stanco. Forse mi aveva aiutato a reagire immediatamente agli improvvisi cambi di direzione e d’intensità del vento ma forse era stata proprio quella seconda dose di caffeina (alla quale sono molto sensibile) a determinare quella subdola contrazione involontaria. Non lo avrei mai saputo. Mi ero comportato come mi suggeriva l’esperienza, pensando di aver preso la decisione giusta ma avevo sbagliato, o chissà, senza quel secondo caffè forse non sarei riuscito a dominare la turbolenza ed il mio errore avrebbe potuto essere anche più grosso. Poi mi resi conto che mi stavo arrovellando inutilmente, dissipando le poche energie che mi rimanevano. La giornata era ancora lunga, sperai che il vento aumentasse ancora in modo che la gara fosse interrotta, così quella notte avrei potuto provare a riposare meglio.
Ma l’intensità del vento rimase nei limiti consentiti, quasi sicuramente quel giorno avrei dovuto fare un altro lancio. Infatti a metà pomeriggio i cinque paracadute della Squadra Italiana si aprirono nuovamente sul cielo di Vrsar. Sotto di noi un paesaggio bello e selvaggio ma non eravamo certo nello stato d’animo ideale per apprezzarlo. Con uno sforzo di volontà quasi doloroso, nonostante la terribile turbolenza, tirammo fuori dal cilindro un lancio quasi perfetto.
Dopo di noi, le squadre che guidavano la classifica provvisoria fecero diversi errori. Tutti capirono che la partita non era ancora chiusa, l’Italia si era ritrovata! Subito dopo quel terzo lancio del primo giorno di gara, pensai che anche la classifica individuale fosse ancora aperta. C’erano alcuni atleti che avevano fatto sempre centro ma, se ero riuscito a fare quello zero con lo stress e la stanchezza che avevo addosso, sentivo che con un po’ di riposo potevo essere in grado di non sbagliare più. Alla fine avremo visto cosa sarebbero riusciti a fare gli altri. Mancavano ancora cinque lanci per chiudere la gara di squadra, più altri due per i finalisti della classifica individuale. Quella sera come tutte le altre fino al termine del campionato, andai a letto molto presto e spensi la luce nove ore prima della sveglia Facevo fatica ad addormentarmi e spesso mi svegliavo durante la notte ma il fatto di avere molte ore per provare a dormire, mi tranquillizzava un po’. In sostanza, poiché non potevo contare sulla qualità del mio riposo, potevo solo cercare di compensare con la quantità. Il quarto, quinto sesto e settimo lancio furono una rimonta entusiasmante; l’Italia tornò in testa alla classifica a squadre ed io anche a quella individuale. L’ottavo lancio avrebbe assegnato il titolo di Campione del Mondo a Squadre. Vincemmo con un margine ampio, quasi umiliante per le altre squadre, così come avevamo fatto quattro anni prima in Cina e come avremo fatto l’anno seguente ai Campionati del mondo Militari. La tenda Italiana fu invasa dalla gente che veniva a farci le congratulazioni ma la gara non era ancora finita. Mancavano ancora il nono e il decimo lancio, cioè la semifinale e la finale della gara individuale. Secondo il regolamento, il nono sarebbe stato riservato ai primi quaranta atleti della classifica provvisoria, poi solo i primi venti avrebbero disputato il decimo e ultimo lancio. Quindi lo scenario di gara sarebbe cambiato notevolmente. Infatti durante i primi otto lanci i cinque componenti di ogni squadra si lanciano tutti insieme da mille metri di quota.
Ora i finalisti avrebbero fatto i lanci uno per volta da ottocento metri, in ordine inverso alla classifica provvisoria. Due anni prima questa esperienza mi era mancata, perché la gara si era conclusa con soli sei lanci e quindi non c’era stata l’apoteosi dei lanci individuali. Psicologicamente c’è una differenza notevole, infatti, durante la gara a squadre i risultati valgono comunque anche per la classifica individuale ma ci si sente un po’ come protetti dalla squadra stessa. Invece nel nono e nel decimo lancio di un Campionato del Mondo sei circondato da avversari, se sei in testa sarai l’ultimo a lanciarti, li vedi uscire singolarmente, uno per ogni passaggio dell’aereo sopra la zona di lancio. Quasi tutti ti tengono d’occhio; chi si trova oltre il quinto/sesto posto della classifica provvisoria sa che quasi sicuramente non riuscirà a salire sul podio ma i primissimi sono ancora in corsa per tutte le medaglie. Sanno che qualcuno, specialmente fra i primi tre, potrebbe cedere psicologicamente, nessuno vuole sbagliare, nessuno può sbagliare. Aspettando il nono lancio cercavo di riposare un po’. Non volevo che la gioia della medaglia d’oro a squadre mi facesse rilassare troppo; gli ultimi lanci, specialmente per chi è in testa, sono i più faticosi. Nella semifinale feci il mio settimo zero consecutivo, dopo quel terribile errore del secondo lancio e naturalmente rimasi in testa. Arrivò la chiamata all’imbarco per la finalissima. In aeroporto, mentre salivamo sull’ultimo aereo, guardai gli altri nove finalisti che insieme a me stavano per affrontare l’ultima prova e mi resi conto di una cosa fantastica: nei primi dieci c’erano ben quattro italiani, tre dei quali del Centro Sportivo Esercito.
Credo che nessuna nazione sia mai riuscita a fare una cosa del genere! Ero in testa con due centimetri di errore, dietro di me uno slovacco con quattro, poi gli altri con cinque, sei … Quando rimasi solo in aereo e fu il mio turno, la mia concentrazione diventò fragile. Sapevo che intorno al bersaglio c’era tutto il mondo ad aspettarmi. Appena aperto il paracadute cercai di individuare chi mi precedeva per valutare la distanza che ci separava, lo vidi circa trecento metri sotto di me, ormai nella fase finale di avvicinamento al bersaglio. Un attimo dopo il suo atterraggio sentii il boato della folla e seppi che aveva fatto centro; quindi era rimasto a quattro centimetri di errore su dieci lanci. Se io avessi fatto zero o un centimetro avrei vinto, con un DUE saremmo stati pari … Il mio avvicinamento al bersaglio fu corretto ma negli ultimi venti metri sentii che stavo cedendo psicologicamente. Fino a quel momento ero riuscito a isolarmi come dentro una bolla di sapone. Vedevo gli altri e gli altri vedevano me ma ero come protetto, distaccato, cosciente e padrone delle mie potenzialità. A pochi metri da terra la mia concentrazione cominciò a svanire, la mia bolla si stava dissolvendo; strinsi i denti, dovevo continuare a controllare la traiettoria del mio paracadute. Nell’attimo in cui atterrai non ero più padrone dei miei pensieri, mancai il centro di pochi millimetri ma vidi bene dove avevo colpito il bersaglio e ancora prima di guardare il display, seppi che avevo fatto UNO. Ero ancora io il Campione del Mondo. Allargai le braccia, quasi per scusarmi di quell’errore, poi gli abbracci e le mani da stringere. Quel campionato fu magico per tutta la Squadra italiana, infatti oltre alle medaglie d’oro nella precisione di squadra e individuale, ottenemmo il secondo posto nella “combinata per nazioni” (miglior risultato Azzurro di sempre).
La combinata è una classifica ottenuta sommando i risultati ottenuti nelle due discipline “classiche”, cioè la precisione in atterraggio e lo stile in caduta libera. Quella medaglia d’argento in combinata per nazioni significa che i paracadutisti militari italiani, non solo hanno dominato la scena mondiale della precisione in atterraggio ma hanno anche dimostrato di essere degli atleti completi. L’arrivo del terzo millennio non mi ha portato via la voglia di gareggiare. Ho continuato a competere, sempre con buoni risultati, anche se non all’altezza dei miei tempi migliori. Con il passare degli anni crescevano le responsabilità, fino a quando, all’inizio del 2014 ho assunto il comando della Squadra. Sono stati tre anni difficili ma ricchi di soddisfazioni. Prezioso è stato il supporto ricevuto dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia. Ho sempre agito in buona fede, con la consapevolezza del privilegio e della responsabilità del ruolo che ricoprivo. Mi scuso comunque per gli errori che posso aver fatto. Negli ultimi mesi del mio servizio attivo molti colleghi e superiori hanno riconosciuto le grandi difficoltà che ho dovuto affrontare al comando della Squadra, esternandomi anche formalmente il loro apprezzamento; questo per me è stato molto importante. Ho lasciato la vita militare e la Squadra del RAS con grande emozione ma con la serenità di chi sente di aver fatto del proprio meglio. I miei ricordi più coinvolgenti degli ultimi anni sono quelli della progettazione, collaudo e impiego della bandiera italiana di mille metri quadrati. Ringrazio la Brigata Folgore e l’ANPd’I per avermi permesso di realizzarla. Ringrazio la Sezione Paracadutismo, della quale ho fatto parte per oltre trentadue anni, la porto nel mio cuore e per me si chiamerà sempre CSE. Vi saluto con la speranza di incontrare tanti di Voi ovunque, magari con il paracadute sulle spalle, o in qualcuna delle cerimonie della nostra FOLGORE.